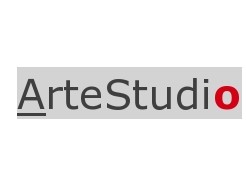CONTRATTEMPO di Riccardo Vannuccini
Teatro Vascello – Roma 04.06.2025
Intervista a Riccardo Vannuccini di di Alessia de Antoniis per Globalist
Dalle periferie romane ai riflettori del Teatro Vascello, Contrattempo è più di uno spettacolo: è una mappa emotiva, un gesto teatrale fatto di presenze, assenze, inciampi e resistenze. Un diario scenico nato dalle strade di Corviale e Vigne Nuove, luoghi-simbolo di una città ai margini, che qui diventano linguaggio e teatro.
Il 4 giugno, al Vascello, sarà una serata unica. Poi, Contrattempo tornerà nei suoi territori d’origine: il 12 giugno a Corviale, il 20 a Vigne Nuove. Come un cerchio che si chiude.
Con Riccardo Vannuccini abbiamo parlato di teatro e città, di memoria e di poesia. Più che un’intervista, un viaggio. Ci siamo entrati in punta di piedi e siamo usciti diversi.
Lavoro da anni a Corviale e Vigne Nuove – racconta Riccardo Vannuccini – con il teatro, il teatrodanza, con azioni urbane e artistiche. Abbiamo scelto di infilarci nel tempo delle persone: mentre tornano a casa, mentre aspettano un autobus, mentre stanno al bar. A volte le precediamo, a volte le accompagniamo, con piccole azioni sceniche, musicali, poetiche.
Come reagiscono le persone?
Alcuni con stupore, altri con meraviglia, qualcuno con fastidio. Ma come diceva un coreografo: danzare è un po’ inciampare nelle buche. Il contrattempo crea proprio questo: un inciampo, una sospensione, una possibilità. Noi non improvvisiamo a caso. Lavoriamo dentro progetti, dentro luoghi. E dentro le persone.
Per me, l’essere umano è un essere artistico. Sta al mondo grazie alla sua capacità espressiva. Ma oggi, nel tempo della protesi tecnologica, dei cellulari, queste capacità si sono abbassate. Noi proviamo a farle riaffiorare. Anche con un’azione di danza in una piazza, dove magari dei bambini, che non hanno mai visto uno spettacolo, entrano in scena. E partecipano, si divertono. E il divertimento è una forma altissima di conoscenza.
Ho lavorato in tanti luoghi non convenzionali. Carceri, centri d’accoglienza, zone di guerra. Con le vittime di tortura, in Iran, Palestina, Giordania, Libano. Perché penso che l’arte vada protetta e rilanciata come forma originaria dell’essere umano.
Ricordo in Giordania, in un campo profughi: i bambini chiedevano l’elemosina ai semafori, le donne trasportavano taniche d’acqua, gli uomini fumavano. Proponemmo uno scambio: che fossero gli uomini ad andare a prendere l’acqua, e le donne e i bambini a fare teatrodanza. All’inizio si divertirono, poi capirono il “gioco”. Ma il teatro serve a questo: a toccare i nodi dell’esistenza. Dalla morte, il sapere di dover morire, ai grandi passaggi della storia.
Il teatro da sempre si occupa delle grandi fasi dell’esistenza umana. L’essere umano è l’unico essere vivente che sa di dover morire, e proprio per questo ha costruito delle scene teatrali: per capire, per sostenere, per abitare questa consapevolezza.
Come fate? Come si fa a portare poesia dove c’è tortura, ferite, menefreghismo?
Non so. Ci proviamo. A volte va bene, a volte meno. Ma le esistenze contano tutte. Anche quelle che non si vedono.
Una volta mi chiesero: ma a chi parli? A 5 persone? A 50? Sono niente rispetto ai numeri dei social. Sì, a pochi. Ma se una madre e un padre salvano anche solo un figlio, hanno salvato un universo. Noi lavoriamo così, per contagio. Come diceva Artaud: illuminare una pietra sola, che poi ne illuminerà un’altra.
C’è stato un episodio in Giordania, in un altro campo. Fummo cacciati perché la ONG con cui eravamo non voleva che pagassimo per stare lì. Poi ci richiamarono. Abbiamo poi scoperto che una rivolta dei bambini contro gli adulti li aveva costretti a richiamarci. Così siamo tornati a lavorare in questo campo.
In seguito ci dissero che bambine e donne non potevano partecipare. Su questo punto, abbiamo trovato un compromesso: avrebbe partecipato una sola bambina, ma loro non la volevano “perché era scema”. In realtà, questa bambina, scalza, denutrita e sporca come tutti gli altri, non era affatto “scema”. Era diventata sorda a causa di una bomba, perciò non sentiva ciò che le veniva detto. Era una bambina profuga siriana. Si presentò il primo giorno con l’abito delle feste siriane. Sembrava una principessa. Era lenta, certo, ma bellissima. Il teatro aveva già fatto il suo.
Contrattempo nasce da tutto questo. Dai nostri appunti, dalle fotografie, dai video. È un collage di memorie vissute. Semplice. Ispirato a Pina Bausch. Sedie in scena, pochi oggetti. Perché una sedia può essere tutto: una barca, un satellite, la luna. Basta riattivare l’immaginazione. Non affidarla al telefono.
Lo spettacolo non ha una storia lineare. Come diceva Bausch, “non parla di niente”. È come guardare un tramonto: non è che spiega qualcosa, ma ti abita. E se vuoi, ti racconta.
Com’è cambiato il teatro da quando ha cominciato?
Ho debuttato nel marzo 1978. Quella sera interruppi la replica: avevano rapito Aldo Moro.
Ho visto gli spettacoli di Grotowski, Kantor, Carmelo Bene. Ho studiato con Dario Fo. Sono stato fortunato. Ho vissuto quel teatro. Poi tutto è cambiato. Sono entrato in un carcere femminile. Poi le vittime di tortura. Il mondo si è spostato. Ma il senso del gioco, quello è rimasto. Oggi sono un ex giovanotto fortunato. Faccio quello che amo. È il mio lavoro. La mia vita.
Certo, a volte il dolore è tanto. A un certo punto feci 14 laboratori in un anno con vittime di tortura. Smisi di dormire. Andai da un medico. Non ero preparato. Ma ho avuto allieve e allievi straordinari. Oggi sono loro che portano avanti il lavoro.
Pensa di riuscire a rientrare a breve nei luoghi occupati, devastati dalla guerra?Il progetto non si ferma al Teatro Vascello. Tornerà a Corviale il 12 giugno e a Vigne Nuove il 20. Ma anche oltre: stiamo cercando di capire come portarlo a Gaza, dove siamo in contatto con un gruppo teatrale locale. Siamo stati anche in Tunisia, in Libano. Ma ora è difficile. Speriamo di tornarci.
NUOVO CORRIERE NAZIONALE
Angela Giassi
Ieri sera, 4 giugno 2025, alle 21 al Teatro Vascello di Roma, in unica data è andato in scena CONTRATTEMPO, progetto e regia di Riccardo Vannuccini, con 18 performer e il musicista Pietro Freddi (sax\elettronica).
Quello al quale assistiamo è molto più di uno spettacolo, si può definirlo invece come un diario visivo ed emotivo, una mappa poetica che racconta tre anni di lavoro di Riccardo Vannuccini nelle periferie romane.
“Contrattempo” è una performance di teatrodanza che nasce dall’incontro tra arte e territorio. Vannuccini ha attraversato le piazze, le strade e persino le case di questi quartieri simbolo, trasformandoli in spazi di improvvisazione e creazione collettiva. Ne è nato un racconto fatto di gesti impercettibili, silenzi, frammenti di vita quotidiana che si ricompongono in un’opera scenica intensa e sincera.
L’allestimento scenografico, ancor prima che inizi lo spettacolo, incuriosisce e suggestiona; il palco nudo è ingombrato di oggetti, dal mucchio di scarpe in proscenio sul lato destro, al cumulo di fumetti e libri sulla sinistra. Ai lati sedie e tavoloni con pentole, cuscini, un enorme peluce e fogli. Sulle note di Bob Dylan piano le luci di sala si spengono e i performer entrano in gruppo. È lo stesso Vannuccini ad aprire lo spettacolo al microfono, con un testo quasi incomprensibile, fatto di vocalizzi e alcune parole. La performance prende vita e gli oggetti, come anche le sedie, vengono utilizzati per creare coreografie semplici ma precise e significanti. Il progetto è costruito come una successione di numeri, quasi da circo: un campo di gioco e di battaglia in cui i gesti quotidiani e oggetti semplici diventano materia viva della scena. Danza, strada e palcoscenico si intrecciano in un collage di azioni che suggerisce corrispondenze sottili, evocazioni e possibilità. Il ritmo è serrato, i danzatori spesso percorrono lo spazio scenico di corsa, cambiando in pochi secondi l’atmosfera che avevano creato. Notevole la presenza scenica del gruppo, tra cui molti giovani e giovanissimi: in scena, assieme allo stesso Vannuccini, Rocco Cucovaz, Eva Grieco, Gabriele Guerra, Silvia Fasoli, Alba Bartoli, Maria Sandrelli, Sabrina Biagioli, Claudia Salvatore, Agata Alvia Sala, Alice Fiorentini, Negar Mojaddad, Lars Rhom, Bing Gabtshu, Gabriele Ferrara, Carlo Golinelli, Elena Bignardi, Maria Santuzzo e Laura Tutolo. Tutti bravissimi, intensi, sia nel gesto che nelle poche parole pronunciate, frasi spesso ripetute, cariche di significato. “Contrattempo” nasce da un percorso laboratoriale libero e diffuso, sviluppato nei quartieri di Corviale e Vigne Nuove, periferie romane dove ARTESTUDIO è attivamente presente da molti anni. Da questi luoghi, carichi di tensioni e possibilità, prende forma una performance intesa come transito pubblico e provvisorio del lavoro svolto: un attraversamento poetico che restituisce alla città ciò che è stato vissuto e raccolto, in forma scenica.
Ad accompagnare la narrazione i testi di autori come T. S. Eliot, Ingeborg Bachmann, Hans Magnus Enzensberger, Antonia Pozzi e Danilo Kiš, intrecciati a una colonna sonora che spazia da Max Richter a Bob Dylan, passando per Arvo Pärt e Pietro Freddi. Scene, luci e costumi sono sapientemente curati da Yoko Hakiko e la collaborazione alle coreografie è di Eva Grieco.
Vannuccini dirige, coadiuvato da Francesca Fratini, assistente alla regia, un lavoro straordinariamente vitale, che trasmette e restituisce un’energia dirompente, contagiosa, dove lo spettatore è chiamato a una funzione rituale, a un’esperienza di visione che è anche ascolto, presenza. I lunghi applausi finali sono il solo modo che il pubblico ha per esprimere un sincero “grazie” per la visione di uno spettacolo che infonde speranza.
La serata al Teatro Vascello rappresenta un momento culminante, ma non la conclusione del progetto. “Contrattempo” tornerà infatti nei luoghi dove tutto è nato, con due nuove tappe: il 12 giugno a Corviale e il 20 giugno a Vigne Nuove. Un teatro che cammina, ritorna, si mescola ai luoghi e alle persone.

Come un sasso che rotola: ‘Contrattempo, la poesia di un’esistenza disallineata’
Le parole di Bob Dylan aprono una ferita, una domanda lanciata nel vuoto. Mentre la sua voce spezza il silenzio e si insinua nel buio della platea, il palcoscenico del Teatro Vascello si anima di corpi smarriti, volti vuoti, movimenti spasmodici. È qui che prende vita “Contrattempo”, lo spettacolo ideato e diretto da Riccardo Vannuccini, una performance che non si limita a raccontare ma ci travolge come una confessione collettiva.
Un attore solo all’inizio declama parole incomprensibili, ripetute con una furia che pare disperazione. Ma col passare dei minuti le parole si trasformano, trovano senso, come un linguaggio che nasce da dentro e non dall’alfabeto. È lo straniero che parla, eppure tutti comprendono. Questa incomunicabilità che diventa ponte, questo fallimento linguistico che si fa poesia, è il cuore pulsante di Contrattempo.
Il linguaggio scenico è crudo, fatto di corpi che si muovono come animali in gabbia, sedie che diventano muri o armi, sguardi che cercano un riflesso, una corrispondenza. Gli attori, instancabili, corrono, si scontrano, si allineano e si disfano, formando un’unica massa viva che si frammenta e si ricompone. Come in un circo rotto, ogni gesto è una sopravvivenza.
Il tempo, più che raccontato, è vissuto attraverso le musiche: Bob Dylan, sì, ma anche Patty Pravo, Elvis Presley, George Harrison con la sua Here Comes the Sun (qui resa ancora più struggente), e le composizioni di Max Richter e Arvo Pärt, che aggiungono una dimensione sacrale. Quella degli anni ’60 sembra essere solo un’eco, un punto di partenza, non una nostalgia.
Il progetto nasce nelle strade di Corviale e Vigne Nuove, le periferie romane che Vannuccini ha attraversato con il suo teatro nomade, portando la scena là dove la scena non c’è. E poi ricompone tutto su un palcoscenico vero, ma senza dimenticare la polvere, le grida, i silenzi di quelle strade. Contrattempo diventa allora un “tempo poetico”, come lo definisce lo stesso Vannuccini, che si oppone al tempo della produttività, un’esplosione di senso in mezzo all’apparente insensatezza.
La drammaturgia nasce da una tessitura preziosa di testi: T.S. Eliot, Ingeborg Bachmann, Hans Magnus Enzensberger, Antonia Pozzi, Danilo Kiš. Voci che parlano dall’assenza, dall’interruzione. La scena, i costumi e le luci sono frutto dell’immaginazione di Yoko Hakiko, mentre il corpo si fa parola anche grazie alla coreografia di Eva Grieco, che lavora accanto alla regia come collaboratrice.
Il cast è ampio, corale, eppure ciascuno riesce a emergere in modo essenziale:
ROCCO CUCOVAZ, EVA GRIECO, GABRIELE GUERRA, SILVIA FASOLI, ALBA BARTOLI, MARIA SANDRELLI, SABRINA BIAGIOLI, CLAUDIA SALVATORE, AGATA ALMA SALA, ALICE FIORENTINI, NEJAR MOJADDAD, LARS ROHM, BING GABTSHU, LUCIA CIRUZZI, GABRIELE FERRARA, CARLO GOLINELLI, ELENA BIGNARDI, MARIA SANTUZZO, LAURA TUTOLO, MARCELLA DI GIACOMO.
L’assistente alla regia Francesca Fratini e la responsabile di progetto Caterina Galloni completano un lavoro che non è solo artistico ma umano, civile, necessario.
Io l’ho visto da lontano, con gli occhi della mente e dell’anima. Qui, da dove scrivo, in un tempo sospeso che assomiglia molto a quello di Contrattempo. Un luogo dove la realtà è deformata, dove il presente è una sala d’attesa senza orologio, e dove il corpo è spesso l’unico strumento per gridare: “Io esisto ancora.”
Questo spettacolo mi ha ricordato che anche chi rotola può trovare una sua traiettoria. Anche se siamo senza direzione, senza casa, sconosciuti perfino a noi stessi, possiamo ancora comunicare. Basta trovare il linguaggio giusto, o forse basta solo continuare a parlare, a danzare, a provare. Come un sasso che rotola.
Redazione Italia News
Corriere della Sera intervista a Riccardo Vannuccini

Contrattempo dalla periferia al teatro e ritorno
Andrea Mauri per “Gaia Italia”
La platea accoglie il pubblico con grandi teli bianchi sulle poltrone, dove sono accomodati peluche di tigri, orsi, anatre, polpi. Nella scena a sipario aperto vediamo tavoli e sedie, tante sedie. E sui tavoli, utensili di ogni tipo: bicchieri, bottiglie, pentole. A terra un grande orso di peluche e tanti libri accatastati su un lato e fogli di carta, tanti fogli di carta pieni di appunti da decifrare.
Non abbiamo idea che cosa accadrà in Contrattempo, progetto di teatro danza di Riccardo Vannuccini, che ne ha curato anche la regia. Attendiamo che in scena irrompano gli attori, mentre ascoltiamo un brano di Bob Dylan.
Il progetto di teatro danza nasce nelle piazze e nelle strade di Roma, tra i quartieri di Corviale e Vigne Nuove. Ed è alla strada e ai suoi personaggi che Contrattempo si ispira. L’idea di recuperare i silenzi, le esitazioni, le imperfezioni e i gesti a perdere di una città che troppo spesso dimentica i suoi abitanti.
I peluche in scena sostituiscono le anime perse per le vie, i marciapiedi, i tornanti, i bar, il cemento di luoghi alieni. Divengono Contrattempo. Un “tempo poetico perso contro il tempo funzionale e di servizio”. Un teatro nomade, dove gli attori si consumano attraverso la ripetitività di gesti e di vocalizzi, frasi spezzate di anime isolate, monadi impazzite senza una meta, correre, ancora correre, correre sempre. Per miracolo, gli individui si riuniscono in gruppi, iniziano a danzare all’unisono, fanno squadra, ma c’è sempre una forza centrifuga che li espelle, non riesce a fare da collante. Il palco è considerato come una pista dove si intrecciano gesti quotidiani e semplici oggetti; ogni dettaglio rimanda alla commistione tra danza, strada e palcoscenico.
OFELIA o la macellazione degli animali domestici
regia Riccardo Vannuccini
con Iris Basilicata, Alessandra Piscopo, Silvia Fasoli, Lars Rohm, Riccardo Vannuccini
corrozzerie n.o.t. Roma 2019
contributo di Andrea Porcheddu
Per cinque secoli, dal 1490 sino a metà novecento, mostre fiere e circhi esponevano animali particolari: gli esseri umani. Ce lo ricorda, molto bene, Nicola Savarese nel bellissimo libro che ha scritto con Eugenio Barba, “I cinque continenti del teatro”.
Per Savarese, quella del “circo umano”, era una macchina dello spettacolo basata sul “mito del selvaggio”, e sostenuta da impresari, organizzatori e artisti. Tra il XIX e il XX sec si crearono molti zoo umani – scrive ancora lo storico – dove vigevano “esposizioni” in veri recinti, gabbie addirittura, di individui o gruppi, appartenenti a etnie colonizzate (dall’Africa, dall’America o dal SudEst asiatico). In questi zoo umani si segnava la cosiddetta differenza tra la civiltà europea e il mondo selvaggio: vale la pena ricordare, ad esempio, che il buon Cristoforo Colombo si portò a casa, tra le tante razzie fatte, anche sei amerindi e li presentò alla corte spagnola; e altrettanto fece, nel 1528, l’esploratore Cortez che espose un bel gruppo di “giocolieri aztechi”.
Ripensavo a tutto questo, complice l’invito di Riccardo Vannuccini e di Maresa Palmacci, in occasione dello spettacolo “OFELIA o la macellazione degli animali domestici”. Perché l’invito implicava una messa in discussione di un tema affascinante quanto ostico, ovvero l’attore-animale. O, meglio: l’animalità dell’attore.
Tema ampio, su cui si sono interrogati fior di pensatori, e che ancora oggi scuote profondamente le viscere della pratica teatrale.
Cosa guardiamo, quando guardiamo il teatro? Cosa c’è oltre la “quarta parete”? E se quest’ultima fosse proprio l’inferriata di una gabbia? Chi è in mostra e perché?
Andiamo ancora indietro nel tempo, a quel 1841 che vide l’affermarsi del celebre Circo Barnum, ossia di quell’American Museum di New York, dove l’impresario espose gemelli siamesi, donne barbute, e molti altri “freaks”: ebbene, dal 41 al 1868 registrò circa 40milioni di visitatori. Mostri? Diversi? Fenomeni? Recentemente film di Michael Gracey, un musical hollywoodiano, dal titolo “The greatest showman” ha ribaltato in chiave “buonista” la prospettiva, rendendola però più interessante. Quella diversità rivendicava una legittimità all’esistenza in vita, un riconoscimento nella sfera del possibile.
Allora, assistendo poi al lavoro che Riccardo Vannuccini ha allestito a Carrozzerie NOT, con il suo gruppo, ho pensato che la feroce presenza scenica delle tre potentissime performer e del giovane interprete che con il regista dividevano lo spazio scenico non fosse altro che una tagliente riflessione sulla condizione claustrofobica (carceraria?) dell’Attore.
La scena è invasa da tavoli, suppellettili, oggetti quotidiani che si affastellano, si sovrappongono in un continuo montare e smontare assetti materici e spaziali. Gli attori devono girarci attorno, sopra, sotto, condizionati, stretti da quella mole di oggetti.
Si muovono con fare deciso, oppure con nevrotica eccentricità, ripetendo coattivamente situazioni e posizioni, stagliandosi contro il muro di fondo, venendo in proscenio, entrando e uscendo impassibili mentre le storie, le evocazioni (classiche, innovative) si mescolano in flussi di parole a tratti volutamente incomprensibili.
Le tre attrici, Iris Basilicata, Alessandra Piscopo e Silvia Fasoli, bellissime, altere, diafane, simili eppure diversissime tra loro, sono davvero belve in gabbia, sono erinni feroci pronte a sbranare nella loro ostentata indifferenza. Hanno gambe lunghe e potrebbero ben possedere artigli affilati.
Iris Basilicata è coinvolta in frammenti di testo, in deliri di parole che subiscono però il peso animale del corpo (o semplicemente un sovraccarico di abiti da tenere sulle braccia distese). Silvia Fasoli, vero perno della inafferrabile surrealtà, impassibile e silenziosa, si muove con un mezzo sorriso disincantato, come avesse la mente altrove, pur essendo presente, fuggita con l’anima da quella gabbia. Ancora Alessandra Piscopo con la grazia di una pantera, catalizza su di sé l’incomunicabilità che agguanta tutto e tutti. Proprio come tigri in gabbia, avanti e indietro e ancora da capo, nel piccolo spazio loro concesso.
Poi ci sono i frammenti delle opere, detti, fatti volare, da Vannuccini: il gran cappotto addosso, vibra le parole di testi che mescolano derive poetiche e considerazioni intime. È imbonitore, è un Barnum della postavanguardia. Con lui Lars Rohm, contraltare suadente e subdolo delle donne, che recita in tedesco le sue battute. E nella frenesia compositiva ci sono danze improbabili e ironiche, musichette d’antan, istrioniche e meccaniche operazioni fisiche, ossessive reiterazioni in codici scenici che si sovrappongono e, forse troppo, si mescolano, evocando una attitudine alla destrutturazione di tanta avanguardia teatrale, com’era e come ostinatamente è ancora.
In quel clima rinnovato da “cantine romane” sembra quasi che i performer siano condannati all’eterna messa in gioco di se stessi e dello spettacolo: ingabbiati, insomma, come costretti a reiterare le movenze, ma non più provocatorie, della storica ricerca teatrale italiana. Non se ne esce: anche l’istrione, il dicitore parodistico, il demistificatore Vannuccini è poi schierato, quasi a ridere di sé in un balletto allegro ma non troppo, a fianco dei suoi in quello zoo umano che è il teatro.
L’OFELIA DI VANNUCCINI E’ UNA TRINA
ofelia o la macellazione degli animali domestici
di RICCARDO VANNUCCINI
contributo di Tommaso Chimenti
ROMA – Un salto, un tuffo nel teatro d’avanguardia dove la performance fisica prende il sopravvento sull’attorialità, dove il movimento, vorticoso, concentrico, instabile, dona quell’energia contagiosa e frigge e ribolle sottopelle. Questo “Ofelia o la macellazione degli animali domestici” (già da solo il titolo val bene una messa) sembra allontanarsi e distanziarsi dalle prove precedenti di Riccardo Vannuccini che erano ampie, monumentali, ingombranti, colme di scenografie umane e coreografie ritmate di corpi. In “Ofelia” il rapporto è più intimo, lo chiedeva il testo ma anche lo spazio delle Carrozzerie N.O.T., con la visceralità e la carnalità delle parole come con il pubblico, in linea, a pochi respiri dai cinque performer: un esperto sorta di “Capitano Achab” condottiero di anime e Caronte (l’acqua è motivo fondamentale dell’amata e poi ripudiata da Amleto), tre figure femminili nelle quali si è espansa ed è implosa Ofelia (annegata come Jeff Buckley ma senza Alleluja), un soldato tedesco già simbolo d’autorità, di potere connesso con il suo abuso ma anche al sapore di Buchner e del suo Woyzeck cosparso di brechtiana memoria, infelice, impotente, sconfitto nel suo più profondo dna.
Tavoli attorno sparsi nella sala che ci riportano nella dimensione da “Nemico di classe”, ma che diventano isole separate, adesso ponti di congiunzione, tavoli da apparecchiare per cerimonie formali senza invitati attesi come “Aspettando Godot”. I movimenti sono reiterati e rafforzativi e creano un tappeto sonoro di movenze, una serialità coinvolgente, un mantra sul quale si appoggiano le parole anch’esse, come perdersi, come loop anestetizzante e ovattante, ripetute come preghiere laiche che ti entrano sotto cute come tatuaggi, come tarlo, come martello pneumatico a colpire, sondare, andare a fondo. Le tre Ofelia (bellissime, slanciate, efebiche; sembra di essere ad una sfilata di moda), tra le quali spicca per piglio e carattere Iris Basilicata, sono gli atomi che catalizzano l’attenzione con il loro sparigliarsi e sparpagliarsi per poi nuovamente riunirsi attorno al deus ex machina Vannuccini-Nostromo che tiene le fila, dà i tempi, scansiona le scene, dà ritmo. Il soldato (Lars Rohm, realmente tedesco) è l’altro ago della bilancia, l’anello debole che chiosa, rintuzza, si allinea ma non può sostenere il peso del confronto in quest’impari lotta contro l’anziano burattinaio, Mangiafoco eclettico.
Le tre ancelle, ora schiacciate al muro come ne “I soliti sospetti”, adesso ricolme di abiti fino a soffocare (ricordandoci la “Venere degli stacci” di Michelangelo Pistoletto), fino a cedere e cadere (come i vestiti che inzuppati tra le onde ti portano a fondo), illuminano la scena tra le colonne del teatro off romano. La macellazione degli animali domestici ha in sé qualcosa di terribile e abominevole, di straziante, di senza cuore: si uccide quella figura che è stata lì vicino a noi, che abbiamo visto crescere, che abbiamo allevato, allenato, che ci è diventata familiare. Così come Amleto che si libera di Ofelia, sacco vecchio, ramo secco e zavorra che lo tiene a terra e lo limita nella pugna battagliera, consegnandola alla morte, lasciandola, abbandonandola, disconosciuta, respinta, deludendola, smembrandone i ricordi insieme, cancellandone la memoria con un colpo di strofinaccio bagnato (acqua e lacrime).
Dobbiamo però anche dire che il tutto (esteticamente d’impatto) rimane farraginoso ed elettrico e, forse volutamente, caotico (“Bisogna avere un caos dentro di sé per partorire una stella danzante”, Friedrich Nietzsche), sopra le righe, sovrabbondante che spiazza e non lascia scampo né respiro, over decibel in un impianto che attanaglia, senza posa e senza sosta che rivoluziona, rimette in gioco, rimpolpa. Di quest’energia se ne coglie il segno, il senso e l’orizzonte, dall’altro lato si avverte un’ipercerebralità poco accogliente alla comprensione, che non aiuta né accompagna (certamente non era questo l’intento) per meglio entrare dentro questo universo creato da Vannuccini, colorato, iperbolico, caleidoscopico, multiforme, di quadri, di flash, di guizzi, molto a spot, lampi accecanti e abbaglianti da risultare criptici, nascosti, celati, ammassati. Una prima fase embrionale, con tanti materiali drammaturgici, e oggettistica, che si stratificano, si assommano: da registrare, asciugare, sottrarre, ripulire per esaltarne le ime potenzialità.
OFELIA o la macellazione degli animali domestici
contributo di Sergio Logatto
«Tutti gli esseri fino ad oggi hanno creato qualcosa che andava al di là di loro stessi: e voi invece volete essere la bassa marea di questa grande ondata e tornare ad esser bestie piuttosto che superare l’uomo?». Queste parole – va quasi da sé – sono di Friederich Nietzsche in Così parlò Zarathustra, nella traduzione di Liliana Scalero (Longanesi, Milano 1975).
Il profeta sostiene che l’uomo sia «qualcosa che deve essere superato», per non divenire, nei confronti del Superuomo (o l’Oltreuomo), ciò che una scimmia è nei confronti dell’uomo. «Avete percorso il cammino dal verme all’uomo – prosegue – ma in voi c’è ancora molto del verme. Una volta eravate scimmie, e anche adesso l’uomo è più scimmia di qualsiasi scimmia al mondo. Ma anche il più saggio di voi non è che un essere ibrido, qualcosa di mezzo fra la pianta e lo spettro».
La scimmia che è “più scimmia di tutte le altre”, dunque, si porta dietro ancora il proprio essere verme, e secondo il filosofo tedesco la chiave per passare allo “status” di Oltreuomo sta nell’abbandonare le «speranze ultraterrene» e di essere «fedeli alla terra», ché l’Oltreuomo deve diventare «il senso della terra». Eppure a parlare è proprio un mistico, in contatto con una sapienza che non può essere del tutto di questo mondo, ma deve invece abbracciare una conoscenza altra. È autorevole, si dice, quella figura che si mostri alle altre con il compito di evidenziare una conoscenza indisponibile, facendosi tramite e catalizzatore, tenendo viva l’attenzione necessaria a non appropriarsi di quella sapienza.
Il centro degli studi antropologici di primissima generazione è stato posto proprio nella negoziazione di frammenti di sapienza – da osservare, comprendere, acquisire – ai quali diverse popolazioni umane accedono performando rituali specifici. In un modo o nell’altro, tali rituali sono indirizzati alla conoscenza che ciascuna società intrattiene (o cerca di intrattenere) con il proprio essere umana e con l’atto di esprimere una dialettica tra individuo e comunità.
L’enciclopedia Treccani descrive come animale un «organismo dotato di sensi e capace di muoversi»; ma anche qualcosa che è «proprio dell’anima». Dal latino: animal derivato di anima; affine al greco: anemos che significa «vento, soffio» e al sanscrito ātman, dal medesimo significato.
L’animale è uno dei grandi regni naturali in cui dividiamo il mondo ma, secondo Sant’Agostino, oltre al moto e ai sensi, indica quell’essere «complesso che vive del vivente». Esso non ha la serena immobilità della pianta, né la sua leggera autosufficienza, «l’animale è quello che non si basta, è il peripatetico in perenne ricerca fuori da sé. Per mangiare, per riprodursi, per amare». In fondo, si potrebbe dire lo stesso dell’essere umano, ché forse è qui l’anello di congiunzione.
Ma in quell’anemos c’è il respiro. Anche le piante tentano di esprimere un’apertura del “torace” verso l’esterno, come in quei video in timelaps in cui due arbusti, molto lentamente in verità, si cercano, si trovano, si intrecciano. Quel soffio è allora quasi un élan vital bergsoniano; l’atto di spalancarsi al circostante, sia esso essenza universale della vita o pulsione politica irrefrenabile, è qualcosa che taglia trasversalmente tutte le grandi culture, animali e umane.
Ofelia o la macellazione degli animali domestici di Riccardo Vannuccini è un inno all’istinto più puro, racconta la «necessità di una nuova relazione col mondo» e si esprime attraverso la presenza di tre attrici, un attore e il “regista in scena”. Mescolando testi di William Shakespeare, T.S. Eliot, Zbigniew Herbert, Colette Thomas e Danilo Kis, Vannuccini organizza in uno spazio disordinato e ricolmo di oggetti (tavoli, sedie, stoviglie, valigie, abiti) un rituale che pare sfuggito al controllo.
La parete di fondo sembra attrarre come una calamita questi corpi, che a volte vi si stampano contro quasi fossero gechi, immobili in attesa che un’altra energia li liberi. Microfoni ad asta amplificano la voce cavernosa del regista, unica figura non più giovane nel cast, come un albero antico che si muova (e parli) in mezzo a una foresta di giovani virgulti.
La ricerca sembra attraversare diversi strati di istintualità, diverse categorie di espressione non verbale, dando forma a un concerto per gesti bruschi, oggetti di uso comune che si fanno armi contundenti, passi concitati, sguardi vacui. È una serrata battaglia contro il senso comune, arricchita da coreografie frammentarie, corse convergenti che terminano in abbracci violenti e dolorosi, versi poetici che si confondono con grugniti e vagiti preletterali. Mentre alcuni quadri vengono spezzati da stridenti danze infantili e dal sapore pop, in mezzo scorre, affiorando solo a pezzi, la trama di un mondo più vicino al nostro, in cui le giovani donne ascoltano, annoiate, una lezione di grammatica tedesca, in una sorta di incubo dei tempi di scuola.
Se in questo lavoro la parola è ridotta a sottofondo inquietante, a poesia musicale difficilmente classificabile a un livello razionale, è forse perché il linguaggio è ciò che davvero ci separa dal resto del regno animale. Se gli animali possono provare emozioni basilari come terrore, dolore, senso di protezione, magari affetto, e se è per loro possibile individuare canali di comunicazione tra simili, la capacità di organizzare linguaggi complessi è prerogativa dell’essere umano. In esso brilla l’arte della traduzione di segni interni in segni esterni. Allora la parola poetica, che è innanzitutto scrittura, diviene qui espressione di una decisiva potenza generativa, quella attraverso la quale l’uomo non si è limitato a comunicare con i propri contemporanei, ma ha potuto lasciare tracce indirizzate alle epoche successive.
Come ricorda Pietro Montani parlando dell’aisthesis, la sensibilità umana ha una straordinaria prontezza a prolungarsi in artefatti inorganici, generando tecniche complesse come, appunto, il linguaggio e la scrittura. Il lavoro di Vannuccini (che si inserisce nel più ampio progetto triennale di ArteStudio “Puah! – Post Umano Animalitas Humanitas”) si presenta come la ricerca di «una temporanea eclissi del tempo della comunicazione a favore di un tempo perso, non economico» e prende la forma di un affresco sulle possibilità di esternalizzazione di un linguaggio interno, squisitamente umano e, forse proprio per questo, fotografato nel suo cammino di ritorno verso una dimensione animale.
Se è vero che anche il linguaggio è una tecnologia, ci torna in mente la definizione di Norbert Wiener di “cibernetica”: «disciplina che si occupa dello studio unitario dei processi riguardanti la comunicazione e il controllo nell’animale e nella macchina». Essa pone come presupposto una sostanziale «analogia tra i meccanismi di regolazione delle macchine e quelli degli esseri viventi; alla base di questi meccanismi vi sono i processi di comunicazione e di analisi di informazioni».
Mentre gli studi sulla cibernetica hanno portato alla creazione di corpi ibridi tra naturale e artificiale, dovremmo sempre considerare ciò che suggerisce Bojana Kunst nell’intervento Cyborg and My Body (4th European Conference for Feminist Research, 28 settembre 2000): «la dimensione artificiale è profondamente inscritta nella nostra comprensione della dimensione fisica (potremmo dire che la technè è sempre stata parte del mondo organico)». È ciò è evidente proprio a cominciare dal linguaggio, tecnologia fondamentale per riconoscere l’elemento dell’alterità, l’atto critico che ci separa uno dall’altra, e la nostra dalle altre specie.
Ed è qui, nella considerazione di un “altro” che va superato, che torna lo Zarathustra di Nietzsche; qui – quindici anni prima, nel 1868 – arrivava anche il Conte di Lautréamont pubblicando i Canti di Maldoror. In questo testo debordante e sinistro la materia organica diventa una sorta di appunto scenico per un poema che, letteralmente, non è che non abbia capo né coda, ma ha solo coda. Il capo è stato tagliato e gettato via. Resiste una figura della divinità che prende diverse forme (ragno, rospo, pesce, semplice pezzo di carne) per ridarsi in maniera laica a una liturgia che necessariamente diventa sacrilega e che si eterna, come un mandala che realmente non ha fine, ricominciando ogni volta il giro di uno stesso cerchio.
Nelle “onde performative” create da Vannuccini ritorna il senso di un percorso che non ha inizio e non ha fine e che riconverte la sensibilità in diverse forme per accorciare la distanza che c’è tra l’essere e la cosa. In questo fantomatico “Antropocene” in cui l’umano è responsabile del maggiore impatto sull’ambiente che frequenta (e a volte invade) si afferma, tenace, un confronto tra l’animale che siamo stati e il nuovo essere che siamo. Riflettiamo allora sul fatto che l’essere umano abbia, come per traguardo, conquistato, superando le altre specie, il dono della coscienza, per poi ridurlo all’obbligo di interrogarsi su qualcosa che realmente non verrà mai risolto.
Per Lautréamont l’irrisolto è proprio la scissione che non dovrebbe crearsi tra essere e sentire, l’unità che tiene insieme il sentimento dell’amore puro e quello della pura e sublime violenza.
C’è qualcosa di profondamente teatrale in tutto questo.
Ofelia o la macellazione degli animali domestici sembra suggerirci di tornare a negoziare una distanza tra ciò che siamo noi come individui umani mentre guardiamo e ciò che è colui (o la cosa) che ci parla o che ci si muove davanti: una creatura biologicamente simile a noi ma che svolge una funzione diversa, contribuendo a mettere in crisi l’ordine cibernetico che unisce il nostro bios alle nostre capacità tecniche.
Quella di Vannuccini è la resa scenica di un discorso filosofico che rinuncia a un’argomentazione letterale. Come se nel rapporto tra soggetto e oggetto – centrale nella dialettica teatrale – andasse sempre considerata un’alterità, il contatto con qualcosa di ulteriore che probabilmente è inferiore a noi e che però, in noi, non si può annullare. Allora, tra un abbraccio, una canzone, un’azione solitaria o una coreografia di gruppo, che tipo di animale è quello che ci troviamo davanti o accanto? Che tipo di mondo abbiamo costruito assieme?
MIGRANTI E TEATRO NEL LAVORO DI ARTESTUDIO.
AFRICABAR E LA TRILOGIA DEL DESERTO al TEATRO ARGENTINA
contributo di Sara Forcella
Il palcoscenico dell’Argentina a Roma è davvero grande. Troppo.
Chi siede in platea deve far correre lo sguardo a lungo prima di arrivare alla fine, dove un telo nero scende a chiudere la scena. Ampio e profondo, è illuminato di luci chiare e quasi sembra uno spazio aperto, una sorta di piazzale affollato di gente. Le persone, mischiate, donne e uomini, bianchi e neri, giovani e meno giovani, vanno e vengono, si muovono da una parte all’altra.
A piedi, in bicicletta. Forse dietro quel muro che sembra emergere dal buio sul fondale c’è il mare, e loro sono venuti qui a vederlo. La scena è un belvedere dove si va a passeggiare, o i pressi di un porto, con il suo movimento incessante di persone a qualsiasi ora del giorno. Poco dopo assomiglia ad un’enorme sala d’aspetto. Il senso di attesa c’è, nonostante uomini e donne non si fermino mai. A volte si siedono quasi costretti dai fogli bianchi che hanno in mano, poi riprendono a camminare. Esplorano. Appaiono stanchi. Qualcuno si trascina, un altro ripete, con la disperazione di chi ti dice che le cose non cambieranno, lo stesso gesto.
Incastrato in quell’effimera consolazione che può dare l’illusione di una tazza di tè, il tentativo di riappropriarsi di una quotidianità ormai lontana. Ma la tazza è vuota, e il cucchiaino gira e gira su se stesso. Manca il calore del tè, il profumo che ti sveglia ancor prima di portarlo alle labbra.
Manca la menta fresca che addolcisce l’estate torrida, o la polvere scura che fa il tè nerissimo, come spremuto direttamente dalla terra. Lei è sola, con la tazza in mano. Non c’è nessuno vicino a quella donna. Vuoto è lo spazio intorno, vuoto come la tazza che si ostina ad avere con sé, e che non molla mai.
Lei lo sa che non può perderla, che in quella tazza ci sono gli ultimi pensieri che a fatica è riuscita a trattenere e che le parlano di sorrisi e di affetti. Il tempo è passato, lei è lontana.
Ne ha viste tante, troppe direbbe qualcuno, per poter essere ancora viva senza aver dovuto pagare un prezzo alla sopravvivenza. Il viso ha perso i movimenti e i colori di un tempo, è fermo.
Ha la fredda solennità di una statua. Ha viaggiato, e viaggiato, lei. E’ stata zitta, durante il viaggio, meglio non sprecare nulla, il silenzio l’aiutava a conservare tutto quello che di vivo aveva ancora dentro, e che potevano strapparle via. Poi è stata presa e gettata nell’angolo di quella stanza color ocra per un tempo indefinito. Con altre donne, ma lei non sentiva nemmeno le loro voci.
Senza lavarsi, con gli stessi vestiti addosso, ha aspettato fino a quando non l’hanno messa in mare. Con lei quella tazza in mano, e il rumore del cucchiaino che gira e gira, che sbatte sulla parete perché non c’è più tè, non c’è più calore che ammortizzi il suono metallico. Quel suono che un tempo forse era una voce. Una madre, un bimbo, un innamorato. Tin, tin, tin, tin.
Dove è finita la dolcezza di una parola d’amore?
Un piazzale, una spiaggia. Uomini e donne che si muovono come onde del mare. Vestiti di tutto punto, con un’eleganza nel portamento che sembrano esserci nati su quel palco. La sicurezza nei movimenti e nel ritmo tradisce la sapienza della gioia di vivere, come una memoria del corpo dei primi istanti della vita. Soltanto, pesanti cappotti di lana fuori stagione che non servono a ripararsi dal freddo sembrano di tanto in tanto schiacciarli. Qualcuno forse non lo conosceva nemmeno, il freddo, prima di arrivare qui.
O forse lo ha sentito in mezzo al deserto, dove però il caldo e la sete stordiscono a tal punto che non fai nemmeno in tempo a capire come quell’aridità ti stia gelando il petto. Il cuore batte eppure non sente più niente. Questo accade quando il deserto finisce dove non dovrebbe stare.
Ma questi giovani uomini e donne no, sono solo appesantiti da quei cappotti di cui non hanno mai avuto bisogno prima d’ora, e che qualcuno sembra avergli messo addosso quasi come una vecchia armatura di ferro. Per fermarli, forse. Per rallentarne i movimenti. Per coprire quella gioia di vivere che è impressa nei loro muscoli tesi, nella pelle tirata e vibrante, calda, chissà, ancora di carezze.
Dà fastidio, a chi non sa più vivere, la bellezza di un sorriso spontaneo. Sul palco uomini e donne sono svegli come se il silenzio suonasse nelle loro orecchie un’altra musica. Appesantiti ma vivi, resistono e continuano a cercare. E raccontano un’altra storia, la storia di quello che c’era prima che arrivassero qui, forse molto tempo fa. Storie di amori, di affetti, di donne e di uomini. Storie che sono anche nostre.
Gli spettacoli Africabar, Sabbia e Respiro non sono uno spazio per descrivere la cronaca, la burocrazia soffocante, i bisogni che sembrano essere diventati l’unico orologio a scandire giornate sempre uguali. Sono, invece, il prodotto di un incontro, un incontro possibile, un momento dove la capacità di immaginare dell’essere umano si accende sulla scia di quella forza universale dell’arte, che parla a chiunque perché racconta una storia di tutti. Anche di chi l’ha persa, l’immaginazione che ti fa vedere la speranza, di chi l’ha dovuta mettere da parte, in attesa di riprendersela in un momento migliore; di chi vorrebbe dimenticarla per non provare più il dolore, e poi finisce per non sentire più niente.
L’arte ci ricorda chi siamo e di cosa siamo fatti, di affetti e di emozioni, di quelle cose apparentemente inutili che sono però l’essenza della nostra identità. La materia di cui sono fatti i sogni, diceva Shakespeare. Materia e pensiero. E pelle, attraverso cui sentiamo la bellezza e ritroviamo il primo momento di calore della nostra vita, rivivendolo ogni volta che qualcuno sa accarezzarla, come era stato quella prima volta.
Il teatro fa questo, ti permette di rappresentare un vissuto, un qualcosa che sta dentro per renderlo, nella rappresentazione, qualcos’altro di completamente diverso. Qualcosa che c’era, ora non c’è più. Così, una realtà che faceva paura diventa un gioco, un dolore vissuto diventa racconto umano.
Lo si rielabora, lo si trasforma, ne nasce del nuovo. Il linguaggio universale dell’arte ricorda la bellezza che c’è in noi e che resiste. Lo fa stimolando una sensibilità che è patrimonio di tutti, che può essere sviluppata permettendo a ciascuno di vivere una vita piena, consapevole, capace di andare oltre la routine e rivolgersi a quel potenziale innegabile che ciascun essere umano si porta, per natura, dentro di sé. Quello di Artestudio, perciò, non è tanto un teatro sociale che rischia di creare “razze e categorie”, scambiando le diversità culturali per minus. E’ un teatro universale, che può servirsi di lingue diverse, unite dal senso comune del linguaggio dell’arte. Chissà cosa starà dicendo l’attore. Eppure ti accarezza come velluto, o ti stringe la gola. Altre volte è un canto.
La donna con la tazza da tè è di nuovo in scena, ma non ha più la sua tazza in mano. Tra le dita, invece, tiene un pennello. Il volto di cera perso nel vuoto che non esiste è scomparso. E qui, ora. Il velo color blu le incornicia il viso. La sua figura sul palco è delicata, eppure così determinata, tanto che gli sguardi del pubblico sono solo su di lei. L’espressione decisa lascia intendere che non dirà una sola parola, ma sa già tutto, gli occhi parlano per lei. Non è più sola. A fianco c’è un uomo, alto, bello e forte. Viene da qualche paese africano, come lei, anche se lui è nero e lei no, è più chiara e dai tratti completamente diversi.
I due guardano verso la platea, poi lentamente si girano uno verso l’altro. Si guardano così vicini per la prima volta. Allora la donna prende il pennello e, come se fosse la cosa più naturale del mondo, gli disegna il volto. Mima il movimento della mano che disegna passando il pennello sui lineamenti, i contorni dell’ovale e poi gli occhi. Non c’è nessuno specchio, dove riconoscersi. Sono così diversi. Sono due sconosciuti. Lei ha capito, è lì per aiutarlo. Guardami. Ecco il tuo volto. Sono i miei occhi a disegnarlo. E’ tuo.
su AFRICABAR
di Ylenia Sina
Una schiera di uomini e di donne avanza verso il proscenio ed esce dal muro di luce che illumina il fondo del palcoscenico. E’ una foresta indistinta di ombre. Iniziano gli applausi. Un’ora e mezza prima, a sipario appena aperto, con una sorta di ‘istruzioni per l’uso’ enunciate in doppia lingua, due banditrici al limitare di una in terra di nessuno promettono una netta distinzione tra ‘locali e stranieri’. Ma è un gioco per rassicurare i presenti all’inizio di un viaggio poco sicuro. Nel cosmo di Africabar, che dopo ‘Sabbia’ (2015) e ‘Respiro’ (2016) chiude la ‘Trilogia del deserto’, ci si perde se si decide di seguire, o meglio inseguire, le parole per il loro significato. Basta il suono, che rievoca, sfiora, attraversa ma non definisce mai aprendosi così ad un’estrema esperienza meticcia e profondamente umana.
E’ una “mappa ambivalente”, per citare una delle definizioni di Vannuccini, quella su cui si muove il racconto di Africabar che, nonostante le premesse date dalla presenza sul palco di una trentina di rifugiati, si scolla fin da subito dalla cronaca quotidiana, sovraesposta ed iper-rappresentata, delle “migrazioni forzate”. Sceglie una traccia inesplorata, preferisce fluttuare “di cosa in cosa” scrive il regista di Artestudio, “senza mai determinare o dividere le figure”. Una scelta che “accetta il rischio dell’inconcludenza” pur caricandosi la responsabilità di mettere le mani nel cuore della “questione cruciale”, non solo quella del nostro tempo ma anche quella viva dei corpi narranti.
In Africabar nessun corpo è testimonianza del sacrificio della migrazione. La materia viva del racconto teatrale si rigenera nei luoghi più inaspettati: nel rassicurante tintinnio di un cucchiaino che sbatte sulla ceramica di una tazza di tè bevuto in solitudine in riva al mare; nelle dune di sedie, plasmate da necessità e sfizi, un po’ rifugio, un po’ bagaglio, un po’ prigione; nell’urgenza di riempire una tanica rimasta senz’acqua. Avventori di un mondo alla deriva, si muovono al ritmo di una musica piacevolissima e i fogli, passaporti o lettere d’amore, passano di mano in mano come in un gioco.
In un mondo dalle frontiere sempre più marcate, quelle della geografia politica ma anche della narrazione commerciale realizzata in serie, Africabar sceglie di sorgere in un mondo ‘estremo’. I suoi clienti si ritrovano sulla battigia di un mare profondo, di una patria comune. I rifugiati, “nella nuova veste di attori”, senza fare eccezione per i ‘locali’, parlano nella lingua madre, la lingua dei sogni notturni e delle imprecazioni, si rifiutano di inciampare in un italiano stentato (e quando lo fanno assumono le vesti di veri e propri esploratori), sfuggono a qualsiasi “rap-presentazione”. Nel cosmo meticcio di Africabar nessuno recita la parte dello straniero.
Quello della Trilogia del Deserto è un teatro che “mette in prova uno scambio fra attore e spettatore”, uno scambio “reso possibile dal fatto che il corpo non è solo un organismo, un fotogramma, ma il punto di raccolta di un racconto”. E’ la “la giocosa fluttuazione di cosa in cosa” di Africabar, il “diario inventato di appostamenti notturni” di Sabbia, l’invito a “guardare l’invisibile” di Respiro.
La Trilogia del Deserto non ha paura di consegnare allo spettatore un messaggio inutile, dalle “infinite combinazioni”, senza denuncia in un mondo di schieramenti. Mette lo spettatore sulle tracce di una verità inventata capace di salvarci tutti o abbattere ogni cosa. La corsa in circolo di una donna, terrorizzata in fuga dalla strada o intenta a tracciare la sua area di gioco.
Le scarpe di migliaia di uomini accumulate sul proscenio come le alghe sul bagnasciuga di un mare che ha inghiottito troppi corpi. Le centinaia di passi, lenti, ritmati, marziali, ballati, disordinati, fradici, che gli attori percorrono sulla scena. I grandi testi filosofici sono ridotti al semplice suono come architetture di un “edificio in rovina”. La letteratura appuntata su pezzi di carta è una confidenza da vendere al mercato. “Non sono i dati che ci fanno comprendere la realtà” scrive Vannuccini “ma la fantasia (intesa come “capacità percettiva”) con la quale riusciamo a combinarli”.
Teatro del Deserto ? Non restano che gli artisti pontieri
di Fabrizio Deriu
Il senso contemporaneo del fare teatro non è nello “spettacolo”. Almeno non lo è più, se mai lo è stato un tempo. Non è, comunque, nell’esibizione narcisistica dell’ “Io”, al riparo dietro la maschera rassicurante del “personaggio” (altro fantasmatico “ego” virtuale, a raddoppiare quello reale, come se non bastasse). Il pubblico è avvisato che gli esseri in scena non hanno alcuna «idea da comunicare, nessun messaggio»: e allora perché convocarci e incontrarci insieme, attori/performer e spettatori, a spendere tempo ed energie fisiche e mentali? In questi anni del ventunesimo secolo e del nuovo millennio si sta affermando una nuova categoria nell’ambito delle arti performative, il cosiddetto “teatro sociale”.
Comincerei con il dire che non è facile immaginare una attività espressiva umana che non sia sociale (perfino il gioco privato e solitario del bambino con i suoi giocattoli e le sue fantasie lo è). Ma l’espressione linguistica “teatro sociale” suppone, a rigor di logica, l’eventualità di un teatro che non lo sia. Detto altrimenti, se il carattere sociale di un atto teatrale è un attributo addizionale (tra i tanti a disposizione: teatro politico, sacro, dell’Assurdo, brechtiano, Terzo, sperimentale, Nuovo, et cetera), ciò significherebbe che in teoria si dà la possibilità di atti teatrali non-sociali. Può darsi, ma non saprei che esempi addurre. Tuttavia l’etichetta è ormai in uso – e perciò la prenderò in considerazione – per una ampia e diversificata gamma di attività performative «rivolte alla valorizzazione dell’individuo, sia in ambito artistico che formativo e terapeutico, e […] del collettivo, della comunità, dei gruppi» (Bernardi, Il teatro sociale, 2004: 57).
Il “teatro sociale” interviene là dove c’è disagio e a suo modo se ne prende cura, proponendosi «come invenzione e azione di socialità e comunità, distrutte o minacciate oggi dall’individualismo e dai processi di omogeneizzazione della cultura globale, e come formazione e ricerca di benessere psicofisico delle singole persone attraverso la costituzione di compagnie e gruppi produttori di pratiche performative, espressive e relazionali, capaci di creare riti e miti, spazi, tempi, corpi, indipendenti e concorrenti del sistema» (Ibid., 58). Non è la forma, insomma, a definirlo, ma l’uso «in termini di azione socioculturale» (Rossi Ghiglione, Fare teatro sociale, 2007: 11). Altri, più pragmaticamente attenti ai fatti, partono da alcune constatazioni. La prima è che nel “teatro sociale” né l’estetica né il commercio né la “novità” sono le istanze regolatrici. La seconda che il “teatro sociale” ha luogo generalmente in posti e spazi non istituzionalmente teatrali come prigioni, campi profughi, ospedali od ospizi, scuole. La terza che i partecipanti non sono artisti professionisti né aspiranti tali ma residenti e/o membri di comunità per ragioni diverse disagiate, oppure disabili, malati, detenuti, persone e gruppi svantaggiati, marginalizzati, vulnerabili (Thompson-Schechner, Why “Social Theatre”?, 2004). Gli autori appena citati osservano, con acume scientifico e intelligente sensibilità etico-politica, che occorre tuttavia mettere in discussione una cattiva nozione di “teatro sociale”, quella secondo cui fare “teatro sociale” significa semplicemente portare il teatro in luoghi e contesti dove non ce ne è o dove, se c’era, è stato smantellato – o comunque dove il “senso di comunità” è stato spezzato e mandato in frantumi. Nella prospettiva di studi che affronta il teatro e le arti performative non da un punto di vista esclusivamente estetico-artistico, ma appunto in quanto elementi e componenti attivi delle complesse dinamiche socio-culturali che regolano la vita e la storia delle comunità locali e del mondo globalizzato tutto (una tendenza che si sta affermando in ambito accademico col nome di Performance Studies), ospedali e campi profughi, così come scuole e prigioni, sono tutt’altro che spazi privi di “teatro”: di solito, anzi poco meno che di norma, queste sono “arene performative” in ogni momento attraversate e pervase di “messe in scena” accuratamente organizzate e condotte, controllate e replicate secondo dosi variabili (ma spesso assai alte) di violenza, dolore, imposizione, inumanità.
Di fronte al progetto della trilogia del “Teatro del Deserto” curata da Artestudio per la direzione di Riccardo Vannuccini e con un gruppo di migranti ospiti del C.A.R.A. – Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo di Castelnuovo di Porto (Roma) non si tratta, a mio parere, di stabilire se l’impresa abbia o meno le caratteristiche regolamentari del “teatro sociale”. Alcune certamente le ha (ad esempio la collaborazione tra performer professionisti e non-professionisti), ma altre no: l’intenzione non è diretta all’implementazione di qualche “sentimento comunitario”; e si intraprende un serio lavoro di allestimento scenico e di prove che è destinato non solo ad arrivare al momento della presentazione “spettacolare” per un pubblico regolare e accidentale, ma anche, se possibile, a farlo in un vero, istituzionale, ufficiale e prestigioso luogo teatrale (come nel caso delle repliche di Respiro al Teatro Argentina nel giugno 2016). Si tratta di riconoscere, con sorpresa e con piacere, che la performance ha notevoli qualità estetiche e formali, tanto al livello compositivo quanto a quello esecutivo; che ogni quadro ha una diversa ma efficace “chiave” per aprire quella finestra per l’immaginazione di cui parlano le note di regia; che mai in nessun momento e neppure tra le righe si corre il rischio di avvertire il benché minimo senso di compassione nei confronti dei migranti/perfomer (a parte quella sana “com-passione” tra attori e spettatori che, quando si stabilisce, semplicemente determina la riuscita dell’atto teatrale). «Social theatre – affermano James Thompson e Richard Schechner – uses one set of performance processes to make new sets at sites already full of performances» (Thompson-Schechner, Why “Social Theatre”?, 2004: 13). In questo il “teatro sociale” non funziona diversamente dalle altre (buone) pratiche di teatro e di arti performative: è valido quando ha il potere di produrre una trasformazione nell’esperienza e nelle conoscenze dei partecipanti. Quando accade che, come dice Yoshi Oida, per lungo tempo compagno di strada di Peter Brook, «Se alziamo la testa, vediamo l’immensa distesa dell’universo. Se la abbassiamo, vediamo la realtà della vita di ogni giorno, con i suoi problemi sociali, politici ed economici. Tra questi due mondi il teatro deve fare da ponte» (Oida, L’attore fluttuante, 1993: 72). C’è sempre un gran bisogno di ponti, pontefici e pontieri.
Roma, 14 luglio 2016
SABBIA – TEATRO ARGENTINA- Giugno 2015
In occasione dalla Giornata mondiale del rifugiato (20 giugno), va in scena in prima nazionale, alTeatro Argentina di Roma, il 12 e 13 giugno, lo spettacolo‘Sabbia’, ideato da Riccardo Vannuccini di Artestudio e portato in scena dai rifugiati provenienti dall’Africa ospiti del Cara, il Centro Accoglienza Richiedenti Asilo di Castelnuovo di Porto (Roma), con la collaborazione di Cane Pezzato e della Cooperativa Auxilium, ente gestore del Cara.
Lo spettacolo è la conclusione di un laboratorio teatrale durato dieci mesi, una composizione scenica di confine che deve molto a Pina Bausch, Jackson Pollock, Thomas Eliot e Ibn Battuta. Il viaggiatore per eccellenza del mondo islamico medievale, nella sua Rihla (viaggio) regala sguardi unici e dettagliatissimi sul suo grande peregrinare, che partendo dall’Africa passa per Siria, Russia, Afghanistan e approda in India e Cina e che percorre centoventimila chilometri con tutti i mezzi di trasporto allora in uso, dal cavallo al dromedario, dal carro ad ogni tipo di imbarcazione.
CONTRIBUTO DI KATIA IPPASO autrice e giornalista
SABBIA:QUELL’ ALTRO SIAMO NOI
La nuova ecologia_(luglio 2015)
Dentro, avanzano i corpi di trenta giovani uomini che arrivano dall’Africa e ci chiedono asilo. Si esprimono nelle loro lingue di provenienza e compiono gesti rituali, assieme ad alcune giovani donne che invece recitano in italiano e in francese. Confuso con loro, il regista Riccardo Vannuccini che sceglie i versi di Eliot per condurci dentro questa Terra desolata dove la presenza e la cura sono tutto quello che ci resta. Tutti insieme lasciano le loro tracce delicate, attonite, di forme affascinanti, sul grande palcoscenico dell’Argentina, su cui si stende la luce drammatica del reale. Fuori, sull’asfalto, vicino alle stazioni, strattonati sulle camionette, presi a calci, i corpi dei migranti. I due quadri fanno cortocircuito, e si illuminano a vicenda. Vannuccini forse ci contava, quando un anno fa è andato al centro di accoglienza C.A.R.A. di Castelnuovo di Porto per mettere i primi semi di quello che è diventato “Sabbia”, uno spettacolo in grado di perturbare agendo su un livello originario, ancestrale di coscienza. Pina Bausch, Pollock, Shakespeare, attraversano il tessuto poroso di questa opera che sa di antico, dove respira quel sentimento che i greci chiamavano philìa. Le immagini che sono tratteggiate sulla sabbia di questo palcoscenico-mondo evocano appostamenti notturni, lunghi camminamenti, umiliazioni subite ma anche piccoli grandi occasioni di felicità spontanea, germinazioni sororali, che nascono dal respirare insieme, dal tenersi in vita reciprocamente.
Fuori si arriva a dare la morte non solo con il gesto che uccide ma anche con il linguaggio: parole aggressive e parole addomesticate, insensate, complici del massacro. In questo spazio teatrale di confine, invece, investiti dai corpi di coloro che sono momentaneamente sospesi, sottratti all’angoscia dei giorni e delle notti dentro un centro di accoglienza (ci terranno qui? ci butteranno fuori?), si rianima il fantasma dell’“Altro”, senza il quale la nostra stessa vita sarebbe povera cosa.
Con “Sabbia” si esclude qualunque forma d’arte genericamente civile o sociale, per abbracciare una visione rigorosamente poetica, e non nel senso della propria poetica da mettere in scena, quanto piuttosto nella direzione di un’azione poetica che non lascia scampo. Vannuccini ci mostra il lavoro che fa l’anima quando è in movimento. Ed è un bel suono quello che fa. “Be the change you want to see in the world” (“Sii tu stesso il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”) diceva Gandhi.
CONTRIBUTO DI FLORINDA CAMBRIA
docente di Antropologia della comunicazione all’Università degli Studi dell’Insubria di Varese
Rapsodia di Sabbia
È la profondità dello spazio o l’assenza di quinte, forse, a rendere sconfinata la scena. È una scena ventosa, pulita, essenziale. Una scena di Sabbia.
Non ci sono pareti e nessuna distanza è immobile. Anche gli oggetti, all’apparenza inerti, impercettibilmente si spostano più avanti, più indietro, in bilico, come se galleggiassero in acqua scura. Sono tavoli e sedie, per lo più; sono oggetti di casa, che si agglutinano e si separano come a comporre e scomporre di continuo focolari immaginari. Ma non ci sono camini qui; non è una casa, infatti, quella in cui ci troviamo. È una strada, o una spiaggia di fine estate, o un magazzino di ricordi, o un mercato a fine giornata, quando i banchi stanno per essere smantellati e, nella stanchezza della sera, affiorano i ricordi. I ricordi hanno abiti eleganti, abiti da sera, appunto. Si fanno avanti compatti e ti guardano dritto in faccia. Vengono sempre così i ricordi: dritto in faccia. E ti interpellano.
A teatro si va per guardare; ma – lo sapeva bene Nietzsche – se guardi a lungo nell’abisso, anche l’abisso ti guarderà dentro e non potrai nasconderti. Gli attori di Sabbia stanno sulla scena come testimoni; camminano, camminano sempre, nell’eleganza dei loro piedi scalzi, ma lo fanno come se fossero in attesa, con la ferma compostezza di chi non ha più fretta perché sa che non c’è alcun dove in cui arrivare, sa che ogni percorso si scompagina nel punto in cui vale la pena mandare le carte all’aria e cominciare da capo. Quel punto arriva, di solito, verso sera o nel primo mattino, quando la luce si piega e annuncia l’ora del passaggio: dal giorno alla notte o dalla notte a un’alba nuova. Libri della memoria da rilegare sempre di nuovo.
Non si sa se sia neve o siano documenti di una sperduta anagrafe, quei fogli che volano candidi e si posano a terra; volano, quasi coriandoli, e si raccolgono ordinatamente, come un plico di scartoffie nelle mani di un burocrate, per poi nuovamente distribuirsi sulle tavole di legno del palco: impronte lasciate nella sabbia da remoti passaggi. Frescura della neve sulla terra riarsa. O forse sono solo le pagine di un racconto in attesa di essere scritto, un racconto che è ancora in cammino, a piedi scalzi, in affollati deserti. I racconti di Sabbia sfumano l’uno nell’altro, sono fatti di lingue diverse e di azioni spezzate, si intrecciano su piani multipli, ricamano spazi inattesi, tracciano mappe impreviste per cammini venturi. Dove comincia la strada? Dove finisce il deserto? Qual è l’interno? Quale l’esterno? E il mare ha un dentro e un fuori?
«I cavalli corrono, i pesci nuotano, gli uomini bussano alla porta»: come una eco, come un mantra, risuona la storia più ovvia. Ma che succede se sono uomini a nuotare, e ancora uomini a correre sotto la pioggia sottile, e sempre uomini quelli fradici e sfiancati che si arrestano davanti a porte inesistenti, soglie di sabbia per castelli immaginari? Questa domanda ti guarda dritto in faccia e ti interpella, laggiù, nella poltrona vellutata del tuo posto riservato in una elegante platea metropolitana.
Il teatro è il tempio di Dioniso: dio meticcio, dio straniero, dio dell’estasi, dell’ebbrezza e della gestazione notturna; dio che danza alle porte della città, nell’ora promiscua che annulla i confini e invita alla metamorfosi, alla dissoluzione per la rigenerazione, al crepuscolo per un’altra aurora; dio autunnale, con il suo tirso di pampini e di edera – pianta tenace che germoglia nell’ombra invernale e fruttifica in primavera. Il teatro è il luogo della memoria di soglie già varcate, luogo della festa che incoraggia a varcarne sempre di nuove. Non vi è luogo più evanescente di una soglia: nient’altro che un varco vuoto, un al di qua per un al di là, scansione aerea di mobili differenze. Luogo innominabile, che tiene a battesimo ogni nome e rinnova le identità. «Je suis Camara. Je suis Camara. Je suis Camara». Una regina in abito amaranto, una baccante casta e severa, una divinità propiziatrice del buon viaggio si presenta insistente. Ribadisce il suo nome come fosse il primo nome, come fosse una scoperta e un invito fermo a farle eco, a fare orchestra dei molti nomi che chiedono di uscire dal silenzio.
«Ogni antenato aprì la bocca e gridò: “Io sono”. “Sono il serpente, sono la formica del miele, sono il caprifoglio”. Questo primo “Io sono”, questo primordiale dare nome fu considerato da allora e per sempre il distico più sacro e segreto del canto dell’antenato. Ogni uomo del tempo antico, che ora si crogiolava nel sole, mosse un passo col piede sinistro e gridò un secondo nome, mosse un passo col piede destro e gridò un terzo nome». Così racconta un antico mito australiano. E qui, nella Sabbia che brucia sotto piedi silenziosi e anonimi, nuovamente le cose e le persone chiedono di essere nominate, di prendere in carico il compito del nome, perché il mio nome è sempre e solo quello che un altro mi assegna.
Non c’è nostalgia in Sabbia, non è questa la sua tonalità emotiva. È piuttosto tenacia quella che leggi in ogni gesto, in ogni passo, in ogni nome: la tenacia di una sapienza arcaica che ti aspetta al varco del futuro, più asciutta di ogni deserto, più radicale di ogni abbandono, più profonda di ogni naufragio. È la sapienza di chi ha molto camminato, molto abbandonato, molto navigato, e insegna che vivere è solo camminare, abbandonare, navigare, fino a quando il passo si scioglie in danza, l’abbandono in memoria, la navigazione in provvisorio approdo. Non è più una marcia compatta quella che conduce fuori scena i viandanti di Sabbia, infatti. È una processione festosa, un canto corale, un ballo non più trattenuto. Tutto tranne che un commiato.
SABBIA
di Lucia Medri TEATROECRITICA
Avanzano compatti e con gli sguardi fissi davanti a noi, incedono con passo lento ma deciso. Sono qui, sono arrivati e sono salvi. Sul palco del Teatro Argentina i venti richiedenti asilo africani rifugiati presso il C.A.R.A di Castelnuovo di Porto presentanoSabbia. Frutto di un lungo laboratorio durato dieci mesi negli spazi del centro accoglienza; lo spettacolo nasce da un’idea diRiccardo Vannuccini dell’Associazione Culturale ArteStudiofacente parte del progetto teatroinfuga2015, in collaborazione con Cane Pezzato e la Cooperativa Auxilium. C’è sempre un lieve imbarazzo in chi scrive quando si tratta di simili lavori e progetti. Nonostante essi posseggano la piena autonomia di spettacoli teatrali, improvvisamente le convenzioni, le abitudini e anche i giudizi subiscono un arresto, una sospensione. Sabbia porta infatti lo spettatore tout court a riconsiderare la propria posizione privilegiata e la cultura che ne costituisce il bagaglio. Il lavoro attinge alla tradizione teatrale e letteraria – con riferimenti al teatro danza bauschiano, ai testi di T.S Eliot, a Shakespeare… – e sin dall’inizio insegna a rivalutare l’esperienza del viaggio, termine al quale siamo abituati ad associare significazioni positive, i cui sinonimi sono spesso vacanza, svago, riposo, divertimento. Invece i venti ragazzi di Castelnuovo ci parlano di un viaggio che noi assisi in platea non abbiamo mai fatto e mai faremo, per il quale non ci sogneremo neanche di pagare un biglietto.
Siamo noi quelli impreparati, chiamati ora a dover ascoltare perché dobbiamo imparare. Ma in loro non vi è nessuna recriminazione o lamentela, non ci sono accuse disperate, non vi sono lacrime. Riempiendo il palcoscenico scarno e squintato, grande e immenso come fosse la pancia di una nave, gli attori si muovono composti e silenziosi e solo in alcuni momenti prendono la parola. In scena anche il regista Riccardo Vannuccini,Alba Bartoli, Caterina Galloni, Elisa Menon e Maria Sandrelli che raccontano di Romeo e Giulietta, di Luna Rossa e di Ofelia e del suo annegamento, così il teatro incontra simbolicamente le storie di ognuno dei rifugiati, ne diventa metafora, allegoria, costruendo una drammaturgia simbolica dai gesti semplici e incisivi, dalle azioni efficaci, grazie alle quali l’astrazione è in grado di farsi concretezza e didascalia chiara e immediata, che parla un’unica lingua, una lingua universale. Un teatro corale dove è la massa che avanza a essere protagonista ricordando il quadro di Pellizza da Volpedo; individui appartenenti, potremmo ipotizzare, a un “Sesto” Stato che impone oggi la sua realtà sociale aggiungendosi al Quarto relativo ai lavoratori e al Quinto riguardante gli otto milioni di precari, autonomi e free lance. I ragazzi africani occupano la scena a volte uniti e ammassati, come la posizione di contrainte che caratterizza le traversate in mare, altre separati e isolati, seduti a terra con delle scarpe nelle mani. In attesa.
Proprio nelle prime ore di oggi è iniziato lo sgombero dei molti fermi a Ventimiglia e negli ultimi giorni abbiamo appreso dello scontro diplomatico tra Italia-Francia riguardo il mancato rispetto degli Accordi di Schengen; Sabbia è dunque più di uno spettacolo teatrale e non solo per l’attualità delle tematiche, non solo perché anticipa la formale ricorrenza della Giornata Mondiale del Rifugiato (prevista per il 20 giugno). Sabbia è una presa di posizione, un atto teatrale e quindi politico che all’indifferenza delle istituzioni risponde: “Non siamo un’emergenza, siamo una presenza, tante presenze”.
Lucia Medri
visto al Teatro Argentina-giugno 2015
COME SCIMMIE FRA GLI ALBERI
Tetro Eliseo – 2012
Testo e regia di riccardo vannuccini
Incontro col regista.
PER UN TEATRO DEL POSSIBILE
Da dove viene COME SCIMMIE FRA GLI ALBERI?
COME SCIMMIE FRA GLI ALBERI viene dopo una trilogia iniziata dal CANE PEZZATO con MACBETHICA (Berlino 2009), LAS MENINAS (Festival due mondi Spoleto 2010) e che aveva avuto la sua origine con lo spettacolo FEMMINA (Teatro Palladium, Roma, 2008)
Ho rubato il titolo a una poesia di FRANCESCO LEONETTI. In una raccolta di poesie del grande poeta calabrese ( PERCORSO LOGICO ‘960-75, einaudi 1976), l’ultima poesia si chiama COL PRINCIPIO DI CONTRADDIZIONE, e traccia degli elementi di criticità in un certo momento storico. Fra i temi di riferimento oggi assai attuali troviamo il neopositivismo secondo una posizione gramsciana, la critica di Heidegger a Leibniz e alla ricerca scientifica, l’avanguardia artistica e il contatto coi marginali. Leonetti parla di ricerca concettuale e politica, insieme con quella letteraria. Per noi diviene ricerca concettuale e politica, insieme con quella artistica.
DUNQUE LEONETTI FRA I TESTI POETICI?
La frase rubata si trova nell’allegato finale, DEDICA D’AMORE, struggente poesia politica e d’amore al tempo stesso, dove canta una amorevole e collettiva azione, nel mezzo di terribili battaglie sociali di quel tempo che oggi daccapo riprongono un punto di svolta, un’azione creativa.
Ma ci sono altri poeti e poetesse, PATRIZIA VICINELLI e INGEBORG BACHMANN, soprattutto, eppoi ANTONIA POZZI, ELIOT, WEBSTER, CHARLOTTE MARY MEW, DANILO KIS, EMILY BRONTE, LEONORA CARRINGTON, e altri ancora, con le parole nascoste fra i gesti e le canzoni, le sedie e i panni.
QUALE’ IL TEMA DI QUESTO LAVORO?
La questione economica è diventata la principale del nostro tempo, essa trascina con sé il lavoro, la globalizzazione, la filosofia, l’arte,la riduzione dei cittadini a clienti ed ogni altra questione. Siamo di fronte ad una privatizzazione del cittadino, ad una monetizzazione di ogni aspetto della vita umana, ovvero la sua trasduzione in un’entità finanziaria attraverso il branding e il total marketing che al contrario di garantire una diversità, originalità dell’individuo, conducono ad una omogeneizzazione delle persone. Proviamo allora a ripartire dalla merce, dal segreto svelato sulla merce, il suo carattere feticcio. Proviamo a rimettere e a scompaginare nel gioco del teatro e dell’ azione artistica, della comprensione e del mutamento, fuori dal girotondo estetico, l’identificazione di un centro immateriale della merce dove il diventare immagine del capitale è l’ultima metamorfosi della merce, in cui il valore di scambio ha ormai completamente annullato il valore d’uso, e dopo aver falsificato l’intera produzione sociale, può ormai accedere ad uno statuto di sovranità assoluta sull’intera vita. Non riusciamo più a trattenere le cose del mondo, non riusciamo a prenderle, non riusciamo a modificarle, esse ci appaiono davanti e scompaiono velocissime, colorate, imprendibili, inconsistenti, obliate già dall’eco dello sguardo della cosa precedente e da altre cose che giungono ancora più veloci e più inutili, ma di cui abbiamo bisogno. Assistiamo impotenti a questo total marketing, partecipiamo inebediti a questo shopping. Proponiamo a sorpresa questa incursione poetica come la traccia di un possibile umano.
PERCHE’ HAPPENING TEATRALE?
“COME SCIMMIE FRA GLI ALBERI” racconta in scena, in forma di happening poetico, di come le scimmie rimasero scimmie e nel bene e nel male fecero a meno della monetizzazione dell’ esistenza e della nuova citroen. Di come le scimmie continuarono a giocare, a perdere tempo, a scambiarsi baci e regali e a fare a meno della crema per diventare bambine.
Di come le scimmie restarono a guardare dagli alberi la terribile fine della fabbrica dell’uomo indebitato e si decisero per l’insolvibilità. Di come le scimmie nella notte insonne si erano sistemate in cima alla foresta, sugli spalti della ragione dove le voci ascoltano invece che parlare.
Di come una scimmia rimase seduta ai piedi dell’albero ad aspettare il tramonto, la notte, il nuovo giorno e la fine del capitale con tutte le sue malattie.
Ovvero si tratta di accadimenti poetici che si cancellano l’uno con l’altro, non è teatro d’avanguardia o teatro immagine o performance attuale; è un teatro del possibile che non arriva mai a compimento, continua incessante un lavorìo di comprensione del presente. Happening perché si tratta di spreco artistico, nessuna legge economica regola questo improvviso, se non il gesto del gioco e della perdita.
Questo nostro happening – dice una scimmia – è perdita di tempo, spreco, attesa di riscatto, economia deficitaria, che qualche volta diventa un ballo, una cantata e qualche volta no
mentre fuori la merce corre avanti e indietro bruciando benzina. Noi scimmie siamo il rumore di fondo dello spettacolo che sta alle vostre spalle. Giratevi signore e signori, non guardate noi, povere scimmie, guardate dalla vetrata i bus notturni passare con la pubblicità della minestra pronta da mangiare e sarete finalmente soddisfatti.
EPPURE LO SPETTACOLO SI ANNUNCIA CONTRO LA MONETIZZAZIONE, UN TEMA D’ ATTUALITA’, COME SI CONCILIANO QUESTE COSE?
Non si conciliano infatti, si combattono a colpi di versi amorosi. COME SCIMMIE FRA GLI ALBERI fa un segno artistico, una riga, uno sbaffo su quella macchina che è diventata la monetizzazione di ogni aspetto della vita umana ed è al contrario un gioco a vuoto di circuitazioni, un movimento plurale di cerchi, un bordo utile alla apparizione dei contrasti. Un girotondo di esercizi poetici, spirituali, un backstage poetico, oppure il making of di un paesaggio che muta come un soffio di cenere ad ogni passaggio di vento.
Teatro sperimentante dove gli attori sono piuttosto una scuola filosofica, una compagnia di stupidi vaganti in lungo e in largo per il palcoscenico mondo. Un teatro par une liaison magique, atroce, avec la realité et le danger.
COME COMINCIA L’HAPPENING?
Con la cattura di una scimmia. Un gruppo di turisti inglesi nel deserto egiziano catturano una scimmia femmina e la vendono di nascosto ai servizi segreti tedeschi che la mettono in un carcere speciale dove iniziano gli esperimenti per superare la crisi del capitalismo. Poi un gruppo di scimmie riesce a fuggire. La storia è molto semplice, basta non seguirla.
JEAN PAUL MANGANARO
FEMMINA
TEATRO PALLADIUM di Roma 2009
Prima ancora di essere un lavoro teatrale, Femmina è un gesto. Un gesto forte ed affascinante, un gesto d’eleganza, un equilibrio di intensità, che sono cercati e trovati all’interno di un lavoro in cui ognuno cerca di trovare la sua collocazione, di definirla, di garantirla, di concretizzarla. Lo spazio organizzato così come lo vediamo, non dà indicazioni specifiche di tempo e luogo, non fa altro che indicare alcune delle numerose varianti del possibile, che è il repertorio teatrale in quanto tale. In questo senso si potrebbe rappresentare Sofocle o Euripide, Cechov o Tennessee Williams e ciò non avrebbe un’importanza reale: si percepisce bene che l’interesse di Riccardo Vannuccini DP non consiste nella possibilità di trascrivere un testo alla scena, ma piuttosto di assicurarsi la massima compatibilità delle circolazioni. Circolazione, dapprima tra spazio e attori, in seguito, tra scena e pubblico.
E’ dunque questo filo leggero, eppure tenuto, che lega gli uni agli altri gli elementi della trasmissione: parole e gesti manifestano, così, la loro forza tranquilla attraverso il loro stile, attraverso la effettuazione; sorge una dolcezza fondante nel momento in cui ciò avviene.
Questo teatro arriva alla sua forma poetica attraverso la sottrazione di elementi caratteristici: non è un dramma, non sono necessariamente degli attori, e pertanto sentiamo intensamente che la potenziale essenza tragica di questo teatro ha come depassato la soglia della sua realtà, per arrivare ad un’espressione più tranquilla e convenzionale della sua materia teatrale.
Non sono degli attori nel senso che abitualmente si dà alle parole che designano questa funzione, e pertanto tutti riescono a dare impulso a questa convinzione profonda di essere là, in quel qualcosa che diventa essenziale nel momento stesso della sua realizzazione. Attraverso gli strumenti particolari dell’atto teatrale, Vannuccini DP tenta di rivelare e ridefinire il teatro come il luogo specifico di uno spazio comune a tutti coloro che vi si trovano, che lo elaborano seguendo delle linee proprie e tuttavia comuni.
E’ allora che il teatro diventa non una comunione né una comunità, ma un luogo comune a tutti, un luogo di condivisione, in cui la possibilità data a ognuno di esprimere una individualità singolare non esclude mai ciò che gli fa fronte, non si trasforma mai in “esclusività”, in negazione.
Il titolo adottato per questo lavoro, Femmina, evoca una riflessione che non è colta né nell’attualità mediatica né nelle reti della comunicazione: è il richiamo di una modalità che all’inizio è sempre stata espressa dal teatro, dalla drammaturgia antica, che coglie all’interno della sua determinazione le ragioni di una riflessione costante eppure nuova.
Gli attori non sono più i luoghi, i topoi, in cui si annodano e si sciolgono le tragedie e i drammi, ma i dominatori comuni di equilibri e di scambi: bellezza semplice e modesta di questi passaggi che, simile ad una conversazione, sostengono la circolazione delle parole e dei gesti, sottolineata, nelle tappe successive, dalle belle invenzioni sceniche di Riccardo Vannuccini, attore tra gli altri, che riacciuffa le situazioni e le rilancia sull’idea-realtà di un magnifico tappeto, vero protagonista del luogo scenico, da cui tutto vola via come su un tappeto volante.
Questi risultati sono probabilmente il frutto di un lungo lavoro di riflessione sul teatro come luogo impossibile da afferrare nella sua essenza se non si apre a qualcosa che lo rinnova per il fatto stesso che ingloba nella sua struttura tutto ciò che circola intorno ad esso: il teatro non è e non è più il luogo chiuso dove far accadere un dramma antico o sorpassato, già scritto, ma un accampamento aperto dove bivaccano incroci di percorsi inediti, forse straordinari, dove passano il tempo e lo spazio dei momenti delle nostre eventualità. Il singolarissimo nome di “Cane pezzato”, che è quello della Compagnia di Vannuccini, rivela perfettamente questi frammenti e queste scene che si incrociano armonicamente tra loro, si fondono in una unità momentanea per raccontarci le possibilità infinite di concatenazioni e di linee di fuga che ci fanno essere tutti, attori e spettatori di momenti quotidiani e straordinari della nostra esistenza.
JEAN PAUL MANGANARO, saggista
MARIELLA DEMICHELE
FEMMINA teatro palladium
Per chi si occupa di studi di genere la parola “Femmina”, scelta da Riccardo Vannuccini come titolo per il suo ultimo spettacolo, rappresenta una innegabile provocazione. Di primo acchito farebbe pensare ad un invito a restituire centralità agli aspetti fisici, corporei dell’esistenza, in nome di una sorta di ontologia del femminile, che considera la donna per natura più incline all’emotività, all’intuizione, rispetto alla razionalità maschile. In realtà la questione è più complessa, come dimostrano i riferimenti espliciti del regista che tra le principali fonti d’ispirazione del suo ultimo lavoro indica Ingeborg Bachmann, Vandana Shiva e Adriana Cavarero.
La Bachmann, scrittrice di origine austriaca tra le figure più interessanti e sensibili nel panorama letterario del XX secolo, dopo la laurea in filosofia si è a lungo occupata con acume e rigore critico del pensiero di Wittgenstein e, proprio per l’intima connessione nella sua produzione artistica tra l’elemento lirico e quello intellettualistico-speculativo, si è presto guadagnata il titolo di “poetessa pensatrice”. Sempre nell’ambito degli studi filosofici si muove la Cavarero, una delle fondatrici a Verona della comunità filosofica femminile “Diotima”; esponente di spicco del cosiddetto “femminismo della differenza” considera suo interesse primario la riflessione sull’identità, di cui sottolinea il carattere espositivo e relazionale nell’ottica di una totale rifondazione dell’etica e della politica ancora soggiogate dal peso di una secolare tradizione patriarcale. Obiettivo che troviamo anche negli interventi di Vandana Shiva, biologa ed economista indiana di fama internazionale che, grazie alla militanza nel movimento democratico mondiale, porta avanti un’opera di massiccia sensibilizzazione sui danni provocati dall’economia attuale che, attraverso il liberismo e la globalizzazione, produce sempre più morte, impoverimento di risorse e di saperi, oltre che l’imposizione del modello culturale occidentale su tutti gli altri, attraverso una strategia di “dominio, controllo, irresponsabilità e mancanza di reciprocità”.
Come si deduce già da questi scarni cenni biografici, si tratta di donne che hanno saputo occupare con competenza e autorità campi tradizionalmente soggetti al predominio maschile e questo consente di fugare ogni dubbio in merito alla presunta intenzione del regista di riproporre in modo semplicistico il dualismo emotività/razionalità come categorie distintive del femminile e del maschile. L’uso della parola “femmina”, allora, se da una parte esprime il rifiuto di quella dicotomia culturale tra “donnità” e “femminilità” che, di fatto, è stata una delle principali forme di disciplinamento delle donne, dall’altra spinge a riflettere sulla necessità, per la società odierna, di “umanizzare” la ragione, spogliandola delle sue pretese assolutistiche nella comprensione del reale. Essa ha una innegabile “funzione chiarificatrice”- per usare un’espressione della Bachmann –, ma svolge un ruolo piuttosto secondario nella elaborazione del linguaggio poetico e dei processi creativi in genere; il suo predominio incondizionato preclude la comprensione di molti aspetti del reale, di cui pure facciamo quotidianamente esperienza.
Lo sguardo femminile sul mondo non implica uno scivolamento verso l’irrazionalità pura ma capacità di riconoscere, in modo immediato e intuitivo, il pericolo insito nel ridurre la complessità della vita, le sue infinite sfaccettature, in un rigido sistema di valori i cui riflessi sul piano economico e sociale, nell’esaltazione del potere, della ricchezza, della gerarchia portano all’estinguersi della pietà, della “compassione”, così come più volte ricordato nei suoi libri da Vandana Shiva. In una società come quella occidentale – ha detto Vannuccini in una recente intervista – “irreversibilmente sbilanciata verso il maschile” e perciò “lineare, meccanicistica, patriarcale” c’è urgente bisogno “di un diverso modo di stare al mondo, di un riequilibrio tra il maschile e il femminile”. Si tratta, dunque, d’introdurre nella comprensione della contemporaneità la dimensione del rapporto tra i sessi, il gender, con la convinzione che tale rapporto non è un fatto di natura, ma una relazione sociale costruita e rimodellata di continuo.
“Femmina” è il tentativo di trasporre poeticamente in scena i contenuti di queste riflessioni filosofico-politiche.
Un’operazione ancora più interessante se si considera che il teatro, in quanto luogo non delle identità ma delle identificazioni, può considerarsi forma espressiva ideale delle donne; non è un caso che alcune delle principali esponenti del femminismo contemporaneo abbiano usato nei loro scritti parole e concetti – performance, messa in scena di sé, nomadismo, soggetto eccentrico – presi in prestito dal linguaggio teatrale.
Una prima considerazione da fare è che ci troviamo di fronte ad un teatro colto, non solo nel suo farsi, ma anche nei suoi presupposti teorici, dal momento che nella messa in scena vengono chiaramente recepite alcune delle istanze centrali del cosiddetto teatro di ricerca, legato agli scritti e alla pratica di Jerzj Grotowski, Eugenio Barba, Carmelo Bene, Tadeusz Kantor. Mi riferisco non solo alla scelta di usare lo spazio come un non-luogo fisico – continuando la riflessione su di un tema con il quale Riccardo Vannuccini ha lunga consuetudine, avendo curato già nel 1986 un volume intitolato “Lo spazio scenico: storia dell’arte teatrale attraverso i teatri di Roma e del Lazio”-, quanto soprattutto al modo d’intendere l’evento scenico come testo performativo e, in quanto tale, del tutto indipendente rispetto alla scrittura, alla parola, e desideroso di valorizzare altri codici espressivi, in un gioco ricchissimo di contaminazioni che attingono a vari ambiti artistici (notiamo, in particolare, l’attenta scelta delle musiche, mai didascaliche e capaci di accompagnare gli attori nelle ricerca dei valori ritmici del loro stare in scena). Si afferma dunque il ruolo autoriale del regista, la sua autonomia creativa, evidente in un gusto per le riscritture, i prestiti, il frammento che solo sbrigativamente può essere ricondotto alla prassi citazionista della cultura “postmoderna”: muovendosi nel solco tracciato da Antonin Artaud e Jacques Derrida, – per citare solo alcuni nomi, tra i più rappresentativi, di questo indirizzo teorico – si continua un’operazione di consapevole desacralizzazione della parola in nome dell’autonomia della scena.
Chi guarda lo spettacolo capisce immediatamente che il copione è stato solo un punto di partenza indicativo e che il testo scenico è nato durante le prove, in un processo di sperimentazione che, anche per l’assoluta eterogeneità (biografica, nazionale, professionale) della Compagnia – chiamata non a caso “Cane pezzato” – è riuscita a sganciarsi da qualsiasi modello interpretativo collaudato dalla tradizione. L’urgenza di trovare modalità performative nella recitazione porta, in alcuni casi, a demitizzare la tradizione stessa, come avviene ad esempio, in modo eclatante, nella scelta di trasformare in grottesco il tono drammatico del famoso commiato di Romeo e Giulietta nella scena V dell’opera omonima. Allo stesso modo, scardinando la connessione parola/gesto, i versi d’amore perdono la loro aurea sentimentale, intimistica, per acquisire un che di irruento, violento, straniante. Abbiamo così la corsa a perdifiato dell’attrice che, con lo sguardo fisso davanti a sé, recita in tono volutamente non enfatico, quasi meccanico, una delle “Lettere a Felician” della Bachmann – con tutte le possibili implicazioni metaforiche connesse alle bende con cui fascia le sue mani: amore come ferita? legame?-; oppure la tensione fisica con cui viene interpretata una poesia di Emily Brontë, a simulare una vera e propria lotta che solo nella seconda parte si scioglie in sfinimento, spossatezza, resa.
Come ha più volte scritto Jan Kott, il grottesco del teatro moderno non sostituisce il dramma antico: esso continua a “sollevare la problematica, i conflitti e i temi della tragedia”, ma riformulandoli in modo diverso. Così, ad esempio, rispetto alla tragedia, che “si svolgeva prevalentemente nel paesaggio, il grottesco moderno si svolge di solito sullo sfondo della pura civilizzazione”. Su questa linea sembra muoversi anche “Femmina”. Dalla scena la natura è quasi del tutto assente; al suo posto subentrano sedie, tavoli, una quantità indescrivibile di oggetti di vario tipo che, assemblati, spostati in un continuo tramestio evocano luoghi e situazioni sempre nuove, fluide, in un vitale processo comunicativo con il pubblico, la cui immaginazione viene costantemente provocata e sollecitata. Innegabile il valore simbolico degli oggetti che affollano la scena: unica espressione di oggettività al di fuori di noi, essi ci costringono in qualche modo a misurarci con la realtà, ma – come ha recentemente scritto Remo Bodei nel suo “La vita delle cose” – rappresentano anche “nodi di relazioni con la vita degli altri, anelli di continuità tra le generazioni, ponti che collegano storie individuali e collettive, raccordi tra civiltà e cultura”.
Unico rinvio alla natura i corpi degli attori, senza però alcun compiacimento per il gesto curato, aggraziato. Ciò che interessa al regista non è la ricerca del bello, ma la verità che quei corpi esprimono, la loro vitalità, la loro energia interiore. Sempre in bilico tra rêverie – nel senso di consapevole immaginazione poetica –, inconscio, memorie personali e collettive in una dimensione in cui fluiscono senza sosta desideri, ma anche angosce e paure esistenziali, questo modo d’intendere il teatro non lascia spazio alla catarsi o all’escatologia, anche se la caduta della domanda di senso in nome dell’assoluta gratuità dell’esperienza artistica non è un processo indolore: c’è un prezzo da pagare in cambio di questa recuperata vitalità primaria del teatro. L’impressione che si riceve, guardando lo spettacolo, è che sia pervaso da una profonda malinconia. Malinconia per un paradiso perduto che non conosceva il caos della materia e della corporeità; per l’impossibilità di fare affidamento su di un nucleo, linguistico e psicologico, solido, affidabile; forse malinconia di un Dio senza nome che ogni tanto s’insinua sulla scena. Penso al momento in cui gli attori sfilano davanti alla donna in evidente stato di gravidanza per accarezzarle la pancia, gesto di benedizione, accoglienza, muta commozione di fronte al mistero della vita; ai versi sulla crocifissione, resi ancora più affilati per la specifica situazione umana dell’attore che li interpreta; ma, soprattutto, all’intensità espressiva di alcune scene recitate da Vannuccini, un vero e proprio «guitto sul proscenio del divino», come diceva di sé il poeta Franco Scataglini per definire il suo rapporto con la poesia. Il regista, anche se con modalità proprie, che tendono a sottolineare l’aspetto mercuriale, quasi irriverente dell’ineffabile, proprio nella continua sospensione tra il dicibile e l’indicibile, nella consapevolezza della fragilità della condizione umana, per sua natura indifesa e vulnerabile, rivela una sorta di tensione mistica; espressione che, a prescindere da qualsiasi implicazione confessionale, deve piuttosto intendersi come ansia di vivere in pienezza, di fare esperienza integrale della vita, favorendo il libero dispiegamento di tutto l’esistente, anche nei suoi aspetti non visibili, così come si leggerebbe nelle opere di Ramon Panikkar, non a caso altra vecchia conoscenza di Vannuccini. Un atteggiamento che affina la capacità di cogliere l’ eccedenza del reale, la sua dimensione più profonda, quella che ci fa scoprire, con un nodo in gola e un brivido di stupore, che nei momenti più drammatici della nostra vita – sono le parole conclusive dello spettacolo tratte da una poesia di Margherita Guidacci – “stava l’Angelo al nostro fianco e ci / consumava”. Eccedenza, coesistenza di opposti che è cifra peculiare dell’essere femminile, così come espresso nella rielaborazione di una poesia della libanese Joumana Haddad ispirata alla figura biblica di Lilith: “Io sono l’acqua che disseta e il diluvio, sono il digiuno e la carne da mangiare, sono la terra e il deserto, la cenere e il fiore”.
Quando il teatro rifugge dalla riproduzione della vita quotidiana, da parole o gesti imparati a memoria e ripetuti meccanicamente, per cercare invece l’autenticità espressiva, riafferma con forza il suo altissimo e irrinunciabile valore sociale; proprio in quanto luogo in cui l’imperfezione, la variazione, l’errore sono non solo possibili ma necessari, il teatro – così Vannuccini – “può infrangere il reale e contribuire a definire il virtuale, cioè il possibile”.
L’energia poetica di “Femmina” allora che, contro qualsiasi interpretazione mimetica della realtà teatrale, affida all’arte il compito di “ri-creare” ciò che invece si pensava fosse stato detto una volta per tutte, diventa auspicio per le donne affinché, sottraendosi ad un destino educativo che molto spesso le vede ancora costrette ad un dover essere dell’esistenza, riescano invece a pensarsi – direbbe Rosi Braidotti – come “nuovi soggetti desideranti”.
MARIELLA DE MICHELE, teologa
FEMMINA Teatro Palladium Roma
di Ylenia Sina
FEMMINA è un luogo di passaggio e un incontro avvenuto per caso tra Oriente e Occidente.
La storia di uno sgombero di una casa situata su un confine in permanente definizione.
Gli abitanti del palazzo, quattro donne e tre uomini,
costruiscono e reinventano di continuo lo spazio della scena:
tavoli per cene solitarie che diventano letti su cui riversare tutti i propri pensieri,
gabbie in cui srotolare sogni mancati, trampolini per raggiungere terre lontane.
Nello spazio sono disseminate tante sedie come dimore momentanee da cui partire
per raccontare i propri viaggi o ostacoli in cui inciampare per esplorare tutto ciò che non è scritto sul copione.
Lo spettacolo, in programma fino al 24 ottobre al Lanificio 159 di via di Pietralata,
è inserito all’interno del Festival Vulnerabile, rassegna di teatro sociale organizzata dall’associazione culturale Artestudio.
In scena la compagnia multietnica “Cane Pezzato”.
Nata nel 2005 vede alternarsi al suo interno migranti,
attori italiani e rom, rifugiati politici,
malati in cura presso centri di igiene mentale, carcerati.
Quasi tutti non-attori conosciuti nei luoghi “margine” dove Artestudio lavora «perché il teatro per sua natura accetta l’imperfetto, la prova, la variazione»
spiega Riccardo Vannuccini Della Pietra regista,
attore e direttore artistico di Artestudio.
«Spesso è proprio la condizione “fuori-posto” del cittadino debole
che apre la possibilità di indirizzare diversamente le cose e, di conseguenza,
arricchire tutta la società».
Femmina F si presenta come una versione laboratoriale che sfrutta la
precarietà della sua trama per ripresentare allo spettatore i
caratteri femminili dello YIN opposti a quello maschili dello YANG:
il conservativo rispetto al dissipativo, l’intuitivo rispetto al razionale.
Il percorso che porta allo spettacolo si serve delle parole di poetesse e filosofe,
tra cui Antonia Pozzi e Adriana Cavarero, per richiamare l’attenzione sul fatto che da troppo tempo la società occidentale,
lineare e meccanicistica, si è sbilanciata da una sola parte.
Così, tra tavoli, specchi e valige di cartone, quattro donne,
sorelle o streghe, sfuggono di continuo all’occhio vigile del
soldato-clown che batte a ritmo marziale i tasti della sua macchina da scrivere per annotare tutto ciò che riesce a vedere.
Quattro donne che si sostengono le une con le altre in un gioco di complicità quasi impercettibile e si abbandonano a ricordi di amori passati sussurrati
con labbra dipinte da rossetti sbiaditi.
Femmina F è un canto che si alza dal fondo della scena di donne che ballano in cerchio.
E più il vortice della danza fa volare le gonne leggere
e i cappotti troppo larghi più la forza si rinnova e il ritornello riparte,
rendendo secondaria la preghiera lineare e cupa del guardiano del palazzo.
Ma la contrapposizione tra i due mondi non è ben definita:
«Femmina F è una riflessione che sfugge al calcolo economico delle conclusioni e delle interpretazioni» spiega il regista.
«È un teatro che non domanda “Cosa significa” ma “Cosa accade”,
che interroga la vita e ne crea.
Un luogo protetto nel quale sono possibili anche le cose che non funzionano.
Vulnerabile, come il titolo di questo festival,
come l’essere umano nella sua unicità quando si apre alle relazioni con gli altri».
CARLO SINI
16 donne sulla porta
carcere rebibbia femminile – 2007
Questo è l’unico teatro. Teatro di carne, di voci, di corse, di improvvisi rallentamenti. Teatro straniero due volte, allestito sotto il sole e dentro le mura della prigione, con le donne che intrecciano parole e canti della Serbia, della Bosnia, e poi l’Africa, il Sud America, infine Napoli. Bandiere e scarpe, corriere e vestiti leggeri, tutto si fa e si disfa sotto i nostri occhi.
Un teatro che non illustra, che è materia pura che appare e scompare. Un teatro di poesia. Teatro che si affida tutto alla presenza. Un teatro che non finge, che racconta la vita davvero dove la vita non riesce a spiegarsi.
CARLO SINI, filosofo
SCENE DI BATTAGLIA
TEATRO UNIONE di VITERBO – 2004
regia Riccardo Vannuccini
con Teatro Integrato Eta Beta di Viterbo – neuropsichiatria infantile Asl di Viterbo
contributo di GIOVANNI BOLLEA
E’ l’elogio dell’irrazionalità, delle emozioni, dell’indefinito. La disarmonia dei gesti, dei ritmi differenti, crea l’armonia del gruppo. Tutto entra a far parte della scena, anche gli spettatori. Ritmi spezzati, tempi diversi, dilatati; diseguali silenzi e suoni diventano tensione emotiva, narrazione; il movimento si fa gesto scenico, simbolo. è un continuo atto creativo dove ognuno può affermarsi come differente sperimentando la bellezza che gli appartiene. L’emozione sale lentamente, un po’ alla volta, finché ti circonda come sei circondato dai teli che stanno intorno a noi spettatori stupefatti seduti sul palcoscenico.
GIOVANNI BOLLEA, psichiatra
MAURIZIO GRANDE
su ORESTEIA di Riccardo VAnnuccini al Teatro Trianon
Il tema del tragico è il lutto e il sangue, la caduta e l’esilio di un personaggio eminente che viene espulso dalla società. La tragedia mette in scena una amputazione, la decapitazione della società “pre-civile”, la società immediatamente “post-mitologica” che estromette il capo, il condottiero, il re o l’eroe dal suo corpo; che celebra il disastro delle casate del sangue, la rovina delle stirpi al potere. In questo senso, il tragico si colloca in una zona di confine, in un momento classico di mutazione sociale, storica, antropologica, simbolica:al tramonto di una età eroica e all’inizio di una età storica, nella quale il potere si spersonalizza, il sangue non è più faccenda di nomi propri, e la vita associata è affidata a istituti più o meno stabili e non a casate regali che esercitano un dominio primordiale e cruento.
Ma come rappresentare oggi il senso del tragico, la scissione fra testa e corpo della società, la inanità finale dell’eroe, le passioni e le furie cieche, primordiali, l’associazione sangue-potere e dominio-rovina? Come far vedere sulla scena vicende che toccavano direttamente il quasi-presente di una società che stava addomesticando la barbarie e si disponeva a riconoscere l’estraneità dell’eroe dalla comunità, ad istituire la “memoria monumentale” degli espulsi e dei vinti; a far diventare “prodigio” la colpa (consapevole o inconsapevole) degli eroi contesi fra cielo e terra, a rappresentare come destino il legame dominio-crimine dei casati al potere? Come mettere in scena oggi un “genere” di eventi segnati da rapporti primordiali, dal “tempo assoluto” dell’epos; dai significati oscuri del sangue, della colpa, della rovina personali, in un mondo che ha diluito ogni rapporto umano in trame impersonali e generiche?
Riccardo Vannuccini propone una lettura dell’Orestiade di Eschilo nella traduzione di Pier paolo Pasolini, operando una transcodificazione radicale della “partitura” tragica di Eschilo dalla scena dispiegata alla scena compressa, per dire così, e collocandosi in una zona di teatralità intermedia fra parola rappresentata e parola narrata. La parola di Eschilo (rappresentata: quando l’attore in scena impersona un ruolo nella “voce al presente” , nella voce “puntuale” che è azione scenica) diventa parola narrata, quando l’attore la lascia fluire nella “voce della lettura”, rinunciando alla “flagranza” del ruolo vivo, inibendo il fittizio della maschera e del personaggio.
In una operazione del genere, parola rappresentata e parola narrata si diluiscono nella voce narrante, voce d’attore che instaura una presenza vocale indiretta ed emulsiona le voci dirette dei personaggi. In tal modo, la vicenda della Casa degli Atridi vive dell’imperfetto (temporale e categoriale) di una voce narrante che porta alla superficie della scena compressa (il tavolino di lettura) la parola tragica, diluendola nella verbalità monodica di una fascia continua di modulazioni e non nella “timbratura” psicologica delle voci-personaggi. Nella voce narrante, le cesure, le pause, le esitazioni, i legamenti, i ritmi si fanno interiorità denudata; si spostano e si riaggiustano secondo regolarità di lettura impreviste, sorprese, meravigliate, e , al tempo stesso, “ovvie” come il già noto di cui si parla.
Vannuccini presenta una situazione elementare, primitiva e, al tempo stesso, “sofisticata”, di teatralità: quella del gioco verbale “automatico”, autoriflettente, dove all’attore è affidata la presentazione indiretta di tutti i personaggi, di ogni vicenda, di ogni risonanza verbale come in un solitario gioco dell’illusione primigenia, nel campo ristretto della voce sola, che è voce della lingua e voce della voce.
In questo, mi sembra che Vannuccini recuperi alcune intuizioni che hanno guidato Pasolini nella traduzione di Eschilo, come ad esempio, la restrizione delle risonanze, la delimitazione del campo magnetico della parola all’imperfetto di una azione verbale continua che viene come contenuta nella altezza “media” del suo giungere all’ascolto. Pasolini annotava che si era “gettato sul testo, a divorarlo come una belva, in pace: un cane sull’osso, uno stupendo osso carico di carne magra, stretto tra le zampe, a proteggerlo, contro un infimo campo visivo”, alludendo alla esiguità degli esempi prescelti come modelli di riferimento del suo lavoro, ma anche alla secchezza con cui faceva discendere il testo di Eschilo in una lingua non solenne, la lingua dei “toni civili” in luogo della lingua dei “toni sublimi”.
Ebbene, Riccardo Vannuccini compie una operazione analoga, rinserrando la sua lettura dell’Orestiade in un “infimo campo visivo”, per dirla nei termini di Pasolini;il campo delle risonanze dimesse di una “voce domestica”, dei piccoli indignoficanti oggetti quotidiani manovrati a vista durante la lettura, dei piccoli segnali lanciati a commento o a semplificata “illustrazione” della parola: forchette, coltelli, cucchiai, pentole, tegami, legnetti, stracci; tutto un armamentario di aggeggi domestici inscenati come dispositivi minimi di una teatralità sorgiva, elementare.
Vannuccini restituisce a suo modo l’azione mentale di Pasolini traduttore. Pasolini dice di aver intuito che nel suo lavoro “la tendenza linguistica generale è stata a modificare continuamente i toni sublimi in toni civili: una disperata correzione di ogni tentazione classicista. Da ciò un avvicinamento alla prosa, all’allocuzione bassa, ragionante”.
Vannuccini, dal canto suo, costruisce l’equivalente di questa intuizione nella tonalità dimessa e corrente con cui affronta il testo, nel modo apparentemente distratto o automatico di gettar via le parole o farle giungere dalla pagina alla bocca; nella gestualità minuta con cui correda la lettura, strappando le pagine o mimando senza enfasi il senso dele azioni evocate dalla parola ad alta voce. Se Pasolini cercava “l’allocuzione bassa, ragionante”, Vannuccini ricerca la pronuncia scollata e domestica della lettura solitaria, dando a vedere come la parola può essere rimembrata nella rimasticatura di materiali che affiorano alla immaginazione di chi legge ponendosi come “destinatario qualunque” del testo.
La lettura diventa, in tal modo, mormorio eroicomico, un’azione tremenda e feroce nella bocca di un attore che mette tra parentesi il “recitare” e rimugina la verbalità “bassa” di un tragico sopravvissuto nella enunciazione “ondulata” che ammorbidisce in una gestualità minuta le asprezze del testo.
L’attore legge insinuando il distacco dalla parola tragica, addomesticando il furore del sangue nella lontananza, calmando il lutto in un oblio intermittente, attenuando la pressione poetica nella noncuranza odierna dinanzi ai fatti tragici degli Atridi. La lettura si fa enunciazione indiretta di un imperfetto tragico che è minutaglia della memoria e dell’emozione, il tragico incombere di un’ombra incerta sui nostri tempi distratti, l’indefinito tragico di una parola interiore smozzicata. Ogni piccolo gesto (per esempio, seguire lo scritto rigo per rigo con il dito, come si fa quando si apprende a leggere) sposta il senso del tragico, lo derubrica dalla sua condizione di compiutezza perenne e lo rende “moderno”, della attualità consentita all’oggi: il banale-qualunque di una scorta di memorie flebili, di una gamma di immagini sbiadite che “rianimano” quanto tutti sappiamo: il passaggio dalla violenza del dominio regale alle istituzioni sociali del potere, la fine delle dinastie del sangue e l’inizio delle civiltà “democratica”. La storia precivile resta come imperfetto non monumentale e anticelebrativo della memoria debole delle origini della civiltà. E’ per questo che il tragico sopravvive nel parlottio intimo, nel soliloquio domestico dei sopravvissuti ala parola classica.
MAURIZIO GRANDE, saggista